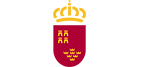Lidia Ravera a metà strada tra il ’68 e il ’77. Viaggio tra le pagine di porci con le ali
Matteo Re
Universidad Rey Juan Carlos
Riassunto: in questo articolo si analizza uno dei romanzi più rappresentativi dell’epoca della protesta giovanile italiana. Porci con le ali, pubblicato nel 1976, si colloca infatti tra il ’68 e il ’77 vale a dire tra due momenti storici che vanno dalla ribellione studentesca alla deriva violenta dell’Autonomia. Il centro della nostra ricerca sarà proprio quello di collocare questo romanzo all’interno della società in cui è stato concepito.
Parole chiave: Italia; Letteratura italiana; romanzo; Sessantotto; 1977; violenza politica.
1. Introduzione
Dall’inizio del XX secolo in poi, il concetto di provocazione ha trovato sempre più spazio sia nell’arte che nella letteratura. Nel campo artistico, potremmo in realtà retrocedere sino alla fine del XIX secolo, citando le opere del realismo trasgressivo dipinte da Gustave Courbet. Potremmo anche soffermarci sulle innovazioni stilistiche adottate dagli impressionisti, il cui allontanamento dall’accademia artistica suscitò scalpore e un innegabile rifiuto da parte dei puristi dell’arte figurativa di quell’epoca. Ma non vi è dubbio che il vero salto di qualità, in quanto a trasgressione e provocazione, sia avvenuto con l’abbandono dell’immagine o attraverso la distorsione stessa di ciò che veniva raffigurato. Il movimento cubista, la versione tubista proposta da Fernand Léger, in concomitanza con il futurismo italiano, sono chiari esempi di scomposizione dell’oggetto e del superamento sia dell’unidimensionalità del quadro che della tridimensionalità dell’oggetto rappresentato.
Si arrivò così alla scomparsa dell’oggetto per lasciare spazio al colore e alla geometria. Il movimento del Blaue Reiter fu un precursore di questo abbandono dell’arte figurativa. Artisti quali Kandinskij, Paul Klee, Franz Marc portarono alle estreme conseguenze questo concettualismo visivo. Non dimenticheremo l’orfismo di Robert Delaunay o il dadaismo di Hans Arp e Marcel Duchamp o esempi interessanti come il lavoro sul colore realizzato da Frantisek Kupka o l’astrattismo di Francis Picabia e Piet Mondrian in un momento in cui la tecnica artistica permetteva la riproducibilità in serie delle opere d’arte (Benjamin 1991: 42)1. Questi sono solamente alcuni, pochi, esempi di come l’arte abbia oltrepassato o superato la figura passando al concetto astratto di raffigurazione artistica. Un passaggio quasi impensabile sino alla fine del XIX secolo. Ciò che veniva considerato artistico, sino a quel momento, non poteva prescindere da un vincolo temporale elevato (nobile o regio) o divino.
Anche nei casi in cui la complessità dell’opera era elevata -citerei per esempio la genialità del trittico il Giardino delle delizie di Bosch, una pittura del XV secolo, ma in cui si intravede un Joan Miro ante litteram- l’artista non si allontanava dalle tematiche divine o nobili. Questo vale almeno fino a Goya e alla sua maja desnuda, che provoca il primo piccolo/grande cortocircuito all’interno del tradizionalismo artistico. La nudità non è, evidentemente, l’oggetto della polemica, del resto il nudo (sia femminile che maschile) fa parte dell’arte e della sua evoluzione storica. Le statue greche e romane rappresentavano dei nudi fantastici che nessuno si azzarderebbe a coprire tacciandoli di nudi osceni, a meno che non si voglia fare un grosso dispetto a un presidente straniero in visita a Roma, come è avvenuto qualche mese fa in Italia. Ma la nudità di Goya provocò il rifiuto da parte dei benpensanti dell’epoca, perché non era chiaro chi fosse questa donna senza veli. Dal suo atteggiamento provocante si poteva addirittura ipotizzare che si trattasse di una prostituta. Sacrilegio senza precedenti quello di rappresentare artisticamente la bassa società, in più se in atteggiamento lascivo2. Manet, più tardi, rappresenterà Olympia in un quadro che ricorda da vicino l’opera di Goya e in cui non vi sono dubbi sul fatto che il soggetto sia una prostituta.
Ma se nell’arte si è arrivati, con il passo degli anni, a una provocazione che fa a volte dubitare del valore reale della produzione artistica (in Italia abbiamo avuto Fontana, ma anche, o forse sarebbe conveniente dire soprattutto, Piero Manzoni, gli artisti dell’Arte Povera e oggi abbiamo Maurizio Cattelan), anche la letteratura ha subito il fascino della provocazione ostentandola nelle pagine di numerosi romanzi. Ricordo, per esempio, il geniale incipit de Lo straniero di Camus; quell’irriverente “Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so”, esempio tragico dell’iconoclastia esistenzialista. Ma potrei anche citare la sessualità esplicita di Bukowski, la violenza dialettica di Boris Vian, senza dimenticare, facendo un salto al passato, l’esaltazione della guerra come “sola igiene del mondo”, “l’amore del pericolo”, “il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno” dei futuristi. Alla violenza si aggiungerà il viaggio psichedelico e delirante favorito dall’abuso delle droghe, dall’eroina all’ecstasy. William Borroughs e i suoi compari della Beat Generation o Irvine Welsh e gli autori della Chemical Generation sono solo alcuni tra gli scrittori più noti che hanno fatto della descrizione di una gioventù bruciata dagli stupefacenti un loro stile letterario chiaramente riconoscibile. Il romanzo Porci con le ali si colloca in questa sfaccettatura di letteratura provocativa diventando un riflesso del suo tempo (González de Sande y Cruzado Rodríguez 2010).
2. La contestazione
Per capire e interpretare il romanzo Porci con le Ali dobbiamo collocare quest’opera all’interno del periodo storico e sociale in cui è stata concepita. La data di pubblicazione è il 1976, l’anno della svolta nella violenza politica italiana. A giugno, le Brigate Rosse uccidono per la prima volta in maniera premeditata. La vittima, il magistrato Francesco Coco, sarà crivellato di colpi di pistola in una viuzza di Genova. Da quel momento in poi, il salto di qualità che portò al passaggio dalla propaganda armata all’attacco al cuore dello Stato, vide un susseguirsi di attentati e morti ammazzati3. Già in precedenza, tuttavia, alcune organizzazioni di estrema sinistra avevano deciso di imbracciare le armi contro lo Stato così come gruppi neofascisti avevano collocato bombe per seminare morte e terrore in tutto il paese.
Purtroppo, gli anni settanta sono passati alla storia quasi esclusivamente con l’appellativo di “anni di piombo”, in ricordo dei numerosi attentati di diversa ispirazione politica, sia marxista-leninista, che neofascista, che terrorizzarono il paese4. Troppo spesso dimentichiamo che in quel decennio i politici firmarono numerose riforme di cui ci beneficiamo ancora oggi. Ecco alcuni esempi: entra in vigore il nuovo statuto dei diritti dei lavoratori (1970); il divorzio diventa legge di Stato (1970) e resiste al referendum abrogativo del 1974; si introduce il diritto di voto per i diciottenni, sino a quel momento permesso dai 21 anni in poi, riducendo quindi la maggiore età (1972); si regolarizza l’obiezione di coscienza al servizio militare (1973); si stabiliscono nuovi diritti e doveri all’interno della famiglia (1975), assicurando la parità giuridica tra il marito e la moglie e aumentando il potere legale dei figli, si chiude quindi la stagione patriarcale all’interno dell’ambito familiare; viene approvata la legge sull’aborto (1978) (Ginsborg 1989: 469) (Moro 2007: 32).
L’Italia, dopo un fiorente sviluppo economico concentrato soprattutto nel periodo che va dal 1958 al 1963 e che prese il nome di miracolo economico, cominciò a perdere capacità economiche proprio nel momento in cui falliva l’esperienza del governo di centro-sinistra, inaugurata nel 1963. In quell’anno, Aldo Moro formò un governo democristiano che prevedeva la partecipazione del Partito Socialista Italiano. Dal punto di vista della strategia politica l’accostamento tra la Democrazia Cristiana e i socialisti aveva come obiettivo far allontanare Nenni e i suoi da una possibile alleanza con il Partito Comunista Italiano, eventualità osteggiata anche a livello internazionale specialmente dagli Stati Uniti e dall’URSS (Valentini 2004: 269). Le aspettative di un periodo riformista, dinamico, libertario, vennero disattese quasi nella loro totalità. Il paese si immerse in una fase immobilista (Lanaro 1992: 326). La delusione nei confronti di DC e PSI sfociò nel biennio di proteste collettive 1968-1969.
Il 1968 venne definito come l’anno dei giovani o l’anno degli studenti. Il confronto generazionale tra adolescenti o giovani adulti e i loro genitori portò allo scontro tra due concezioni diametralmente opposte del mondo in cui vivevano. I grandi movimenti di massa propugnavano la messa in discussione dell’ordine prestabilito, delle regole, della logica borghese dettata dai loro stessi genitori (Giachetti 1998: 80). Gli universitari esigevano l’abolizione del numero chiuso, la riduzione del potere che avevano i professori-baroni, l’aumento della rappresentatività nel senato accademico e la riduzione del costo delle tasse universitarie.
L’anno successivo fu invece prerogativa dei lavoratori. Nella sua fase finale, nell’autunno caldo, così come si definì il periodo più delicato di quel periodo che precedette l’arrivo degli anni settanta, il mondo operaio si ribellò allo sfruttamento salariato delle fabbriche in cui lavoravano e cominciarono a chiedere dei miglioramenti alla sicurezza del mondo del lavoro e alla stabilità contrattuale. Una caratteristica determinante di questi due anni di lotte fu l’uso della violenza come mezzo per esigere quanto richiesto. Operai e studenti si unirono per aumentare l’onda d’urto delle loro recriminazioni ed esigenze. Ma nel frattempo, e specialmente nel 1969, il terrorismo fece su apparizione con il disseminarsi di attentati di bassa intensità in vari punti della penisola, ma che si conclusero con un tragico evento. Il 12 dicembre di quell’anno, una bomba esplose all’interno della Banca dell’Agricoltura di Milano provocando una strage. Quei 17 morti e gli oltre ottanta feriti furono le vittime inaugurali di una lunga stagione di violenza5. Al terrorismo si accompagnarono le manifestazioni violente di studenti militanti dell’estrema sinistra o della destra neofascista.
Ma il ’68 non fu solo scontri di piazza. Fu molta ideologia. Fu l’incubatrice dei movimenti sociali che da lì a qualche mese nasceranno per diventare il rifugio politico e ideologico per tutti quei giovani fuoriusciti dal PCI per collocarsi alla sua sinistra. Ma quello fu un miraggio che si sgretolò in poco tempo. Il periodo dei gruppi, tra i quali ricordiamo Potere Operaio, Avanguardia Operaia, ma specialmente Lotta Continua per la sua presenza nel romanzo che si analizza in questa pubblicazione, fu un momento di grandi sogni infranti contro lo scoglio del passaggio alla politica attiva (Cazzullo 2006). Fu il risveglio da quel sogno che vedeva alla ribalta i più giovani con la pretesa di collocarli nel centro di una visione politica nuova.
Quando Democrazia Proletaria pretese di unificare quelle organizzazioni che sino a quel momento avevano rifiutato una politica attiva tradizionale, la sconfitta fu molto bruciante. Alle elezioni del 1976 (ricordiamo che quello è l’anno di pubblicazione del romanzo di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice) ottenne solo l’1,51% delle preferenze (Perri 2012).
La contestazione non aveva attecchito e lasciava spazio alla radicalizzazione dell’Autonomia Operaia che sfociò nella violenza più scomposta e confusa un anno più tardi (Grandi 2003).
3. La ribellione letteraria
L’Italia degli anni sessanta era gestita da chi era cresciuto in pieno ventennio fascista. Probabilmente per questo motivo si arrivò alla rottura generazionale tra i giovani nati in democrazia e i loro genitori. Le accuse che i primi rivolgevano ai secondi non erano solo quelle di aver aderito al fascismo; nella maggior parte dei casi infatti provenivano da famiglie di sinistra, molte delle quali comuniste. Il rimprovero maggiormente diffuso era mosso nei confronti di coloro i quali, pur professando un’ideologia antifascista, permisero che Mussolini e i suoi seguaci si impadronissero del Paese e che, una volta conclusa quell’esperienza, non furono capaci di portare a termine la rivoluzione comunista, ma accettarono di scendere a patti con il nemico e optare per il riformismo.
Chi a metà degli anni sessanta era un adolescente cominciava (non certo nella sua totalità, evidentemente) a sentirsi sempre più scomodo in una società che, pur allontanandosi dall’epoca mussoliniana, sembrava mantenerne il rigore e la serietà sino al punto di accentuarne la severità e la convenzionalità borghese. Il primo esempio di questa frattura generazionale, a cui si sommò una certa intransigenza cattolica, coincise con la diffusione di un giornaletto scritto e pubblicato dai giovani allievi del liceo milanese Parini. Quando il 14 febbraio 1966, in concomitanza con la festa di San Valentino, La Zanzara (così si chiamava quella rivista) pubblicò una ricerca realizzata da tre studenti, in cui si analizzavano le abitudini sessuali degli adolescenti di quell’epoca, scattarono denuncia e sequestro del giornale. Il caso La Zanzara balzò nelle cronache nazionali, creando un grande scandalo e mettendo in imbarazzo una società che, nonostante la modernizzazione economica, la partecipazione al progetto europeo, la pretesa di essere all’avanguardia e alla moda si manteneva invece su linee molto conservatrici e poco recettive a cambi strutturali. Forse è anche per questo che l’esperienza del centro-sinistra non apportò nessuna riforma e si caratterizzò per il suo immobilismo, perché la società italiana sembrava ancora anchilosata su posizioni senili e tradizionaliste.
Seguì un altro scandalo, anche se di minore intensità rispetto alla pubblicazione de La Zanzara. Don Lorenzo Milani, un prete che insegnava come maestro in una scuola di un piccolo paese della Toscana, diresse i propri alunni nella pubblicazione del libro Lettera a una professoressa. Si trattava di un’opera importante all’interno del mondo contestatario di quell’epoca. Pubblicata nel 1967, fu un testo chiave per molti giovani che vissero la contestazione sessantottina in prima linea, il cui messaggio era quello di cercare, pretendere, dar vita a una scuola nuova, che non escludesse i figli delle famiglie meno abbienti, che non abbandonasse al loro destino chi aveva meno possibilità economiche, ma che unificasse e premiasse il merito e non la provenienza sociale.
E si arrivò, quindi, al duro (e inatteso) attacco da parte di Pier Paolo Pasolini nei confronti degli studenti coinvolti negli scontri contro la polizia avvenuti nei pressi della facoltà di Architettura, a Roma, il primo marzo 1968, la maggior parte dei quali erano di estrema sinistra. Il bilancio, a fine giornata, era molto pesante: 77 poliziotti e 54 studenti feriti. Pasolini, intellettuale di sinistra, invece di attaccare la polizia accusandola di aver alzato troppo la mano contro i poveri studenti marxisti, attaccò questi ultimi accusandoli di avere “facce da figli di papà”. I poliziotti ,secondo l’intellettuale, andavano invece difesi:
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai bene
il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,
a causa della miseria, che non dà autorità.
La madre incallita come un facchino, o tenera
per qualche malattia, come un uccellino;
i tanti fratelli; la casupola
tra gli orti con la salvia rossa (in terreni
altrui, lottizzati); i bassi
sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi
caseggiati popolari, ecc. ecc.
E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci,
con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio
furerie e popolo. Peggio di tutto, naturalmente,
è lo stato psicologico cui sono ridotti
(per una quarantina di mille lire al mese):
senza più sorriso,
senza più amicizia col mondo,
separati,
esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha uguali);
umiliati dalla perdita della qualità di uomini
per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare).
Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care (Pasolini 1968).
4. Porci con le ali
Rocco e Antonia sono gli autori, fittizi, del romanzo Porci con le Ali. In realtà questi nomi coincidono con il nome dei due protagonisti di questa storia adolescenziale caratterizzata dall’abuso di scene di sesso esplicito -sia eterosessuale che omosessuale- dall’ossessione per la masturbazione e dall’eccesso di vita comunitaria nel rispetto delle regole del buon militante extraparlamentare. In realtà, i veri autori di questo libro sono Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera. All’epoca della stesura del loro romanzo avevano 28 e 25 anni rispettivamente. Il loro fu un successo strepitoso, con oltre due milioni e mezzo di copie vendute e un richiamo mediatico inaspettato. In fatti, in un primo momento, questo libro doveva avere una diffusione limitata all’ambiente studentesco romano, ma poi si divulgò con rapidità e fu un boom letterario.
La trama è abbastanza semplice, e non ha nessuna pretesa di alto valore letterario. Rocco e Antonia sono due ragazzi minorenni che studiano in un liceo romano. Entrambi militano nei gruppi extraparlamentari. Nonostante la loro giovane età, la politica occupa una parte molto importante delle loro vite. In questo sono ragazzi del loro tempo. Il loro desiderio di cambiare il mondo è spesso confuso e contradditorio, ma non più di quanto possa essere contradditoria la vita di un qualsiasi adolescente.
L’incomunicabilità è sempre presente e l’alienazione, quell’alienazione di gassmaniana memoria (si veda il mitico dialogo tra Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant ne Il Sorpasso), fa parte dell’adolescenza. Rocco è cerebrale, ma è insicuro e indeciso come sono insicuri e indecisi i giovani della sua età, alle prime armi con il sesso e con l’amore.
Il sesso è il grande protagonista del libro, nelle sue varie sfaccettature, soprattutto quelle più provocatorie. Il libro comincia con una scena forte, almeno dal punto di vista lessicale: “cazzo, cazzo, cazzo. Figa. Fregna ciorgna, Figapelosa, bella calda, tutta puzzarella. Figa di puttanella”. Prosegue poi con la descrizione di una masturbazione da parte di Antonia.
In questo libro traspaiono le insicurezze di due giovani adolescenti in un periodo delicato della loro vita. L’età adulta è dietro l’angolo, ma nessuno dei due sembra preparato per viverla. Ci sono troppe incertezze, troppi dubbi sul futuro, che li frenano. Tra genitori e figli vi è un distacco insormontabile. Antonia ha una personalità forte ma allo stesso tempo autodistruttiva. Il suo scontro generazionale con la madre è evidente in vari passi del libro. Il padre di Rocco è un comunista alla vecchia maniera, convinto che il partito agisca sempre nella maniera migliore. Per questo motivo è osteggiato dal figlio che, come molti giovani di quell’epoca, si schiera su posizioni che stanno alla sinistra del PCI. Il genitore cerca di inculcare nel figlio il dogma del comunismo tradizionale, incentivandolo a leggere gli articoli apparsi su L’Unità, su Rinascita, su Nuova Generazione, su Critica marxista, su Riforma della scuola. Naturalmente l’adolescente non legge niente di tutto ciò. Preferisce “lasciare in bella vista” il giornale del gruppo extraparlamentare in cui milita, la cui visione provoca nel padre “un fremito gelatinoso alla pancia”. Il momento politico forse più alto del libro si riflette nello scontro ideologico tra padre e figlio quando il padre chiede: “ma non pensate che solo una grandiosa alleanza di masse popolari, anche cattoliche e democristiane, possa garantire l’avvio di un profondo processo di trasformazione della società italiana?”. La visione berlingueriana del padre è evidente in questa sua domanda al figlio. La sintesi di uno dei dibattiti più duri degli anni settanta, il compromesso storico tra PCI e DC, è sintetizzato in poche righe (Berlinguer 1973). Un concetto così semplice solleverà dibattiti aspri, rotture all’interno di entrambi i partiti e un allontanamento sempre più deciso della parte più radicale fuoriuscita dal Partito Comunista Italiano. Alla Resistenza tradita si aggiunge questo compromesso innaturale tre due forze lontane e da sempre nemiche (Dalmasso 2001: 108-109). Gli extraparlamentari non capirono né l’atteggiamento del partito “dei loro genitori” nel momento di abbandonare le mire rivoluzionarie per accedere a una politica riformista, né tanto meno l’avvicinamento alla “balena bianca” democristiana.
Lo spirito del Sessantotto è presente all’interno di questo romanzo dalla prima all’ultima pagina. Tuttavia, non si tratta di un riferimento compiacente, acritico e assorbente di quell’anno “formidabile” (Capanna 2007). L’ironia con cui lo si descrive porta il lettore a considerare il ’68 in chiave molto critica, a dubitare della sua effettiva formidabilità, intravedendo dubbi e incertezze che ne ridimensionano non solo l’esperienza di un anno fatto di lotte, ma specialmente la sua eredità6.
Vediamo qualche esempio di ciò di cui stiamo parlando. Antonia rimane affascinata da un certo Marcello in una delle tante assemblee studentesche di quell’epoca. Lo descrive così: “è lui, l’atteso Dirigente-nazionale-di-organizzazione-culturale vicina all’area di Classe. Praticamente Dio. Non me lo facevo così brutto. Ma naturalmente mi piace”. Le piace perché il pensiero è comunque un pensiero unico. Non può permettersi di andare contro corrente. Le deve piacere e basta, perché lui rappresenta l’intellettuale extraparlamentare dell’epoca: un uomo di poche parole, serio, che esprime i suoi concetti in maniera arzigogolata e semi incomprensibile. Eccone un esempio: “la mia convinzione che la musica pop sia un equivalente masturbatorio funzionale a una fase transitoria di depressione sublimativa vorrei fosse confermata da fatti”.
Marcello inizia una relazione con Rocco e le scene di sesso omosessuale sono esplicitate senza pudore. Tra i due nasce un rapporto di complicità che a Rocco affascina molto. Con Marcello lui si sente sicuro e protetto.
Anche Rocco finge con il resto del gruppo, anche se poi, nell’intimità, ammette a se stesso ciò che non avrebbe mai il coraggio di riconoscere di fronte agli altri compagni:
“‘Luci Gialle’. Questa rivista è una delle mie angosce quotidiane, perché pare sia assolutamente geniale, fondamentale, scritta da compagni paraculissimi, e c’è continuamente qualcuno che mi chiede se ho letto questo o quello. Mentre io ne ho comprato un numero solo, una volta che mi sentivo particolarmente volenteroso e intellettuale, e mi è sembrata una cosa da suicidarsi dalla noia”.
Qui i riferimenti reali ricordano i Quaderni Rossi e i Quaderni Piacentini, il cui intellettualismo era così elevato da trasformar queste riviste in oggetti di culto, perennemente citate, ma lette realmente da pochissimi militanti (Balestrini e Moroni 1988: 134).
Le manifestazioni di piazza in quegli anni spesso si conclusero in maniera tragica. In molti, soprattutto giovani ragazzi, morirono negli attacchi tra gruppi di ideologia contraria o negli scontri con la polizia. Un capitolo di questo libro è dedicato proprio alla descrizione di un fatto tragico di questo tipo. Antonia sospira: “Quando ammazzano un compagno è sempre una cosa molto strana, quello che senti”. La colpa viene fatta ricadere su “un coglione di carabiniere che ti spara addosso solo perché sei comunista e hai i capelli lunghi”. Ma proprio quell’episodio triste favorisce l’incontro tra Rocco e Antonia. L’emotività di quel momento fa sì che i due ragazzi entrino velocemente in contatto e tra di loro cresca velocemente l’intimità. Marcello esce dalla vita di Rocco, il quale ora dedica tutto se stesso ad Antonia, in un transfert affettivo tipico dell’età adolescenziale. I due si innamorano passando dal primo bacio al “ti amo” nel giro di poco tempo. Ciò che più sorprende di questo rapporto è che il loro amore li porta ad abbandonare i propositi in cui avevano creduto ciecamente (o in cui forse avevano fatto finta di credere) sino a quel momento. Rocco, ad un certo punto, dice, rivolgendosi alla sua fidanzata: “Io e te insieme stiamo benissimo, ma dobbiamo fare attenzione a non separarci dai compagni. Perché è una cosa borghese”. Il pericolo è vivere come una persona qualunque, come i loro genitori, e questo non si può accettare. È Invece importante rimanere parte di un gruppo, non separarsi dai compagni anche se i compagni si sbagliano, si comportano come estranei e riproducono tutti quegli atteggiamenti che sarebbero condannabili nella vita quotidiana borghese. Solo due pagine dopo, Antonia apre il suo cuore a Rocco e gli confessa il suo amore: “ho detto a Rocco che lo amavo. Più o meno che lo amavo da impazzire. Che io e lui, in breve, dovevamo andare a vivere insieme, avere dei figli, che io gli avrei stirato le camicie e che sapevo fare le uova fritte in tre modi diversi”. A questo punto, e dopo aver letto il parere di Rocco sulla vita di coppia che non dovrebbe precludere l’esperienza comunitaria con i compagni, ci si aspetta che il ragazzo rifiuti una visione così borghese della vita coniugale. Antonia invece ci racconta la reazione del fidanzato: “Lui si è fermato, mi ha preso per le spalle, mi ha guardata. Poi mi ha baciata. È stato, più o meno, il primo bacio veramente sentimentale della mia vita […] mi aspettavo da un momento all’altro che dicesse qualcosa di sinistra sul matrimonio” invece Rocco, dopo il bacio appassionato, chiedere solamente alla sua amata di non insistere nel chiamare il loro futuro figlio con un nome strano. Non avrebbe infatti sopportato “quegli esibizionismi da giardinetto, tipo ‘metti subito la maglietta Vladimir Ilic’”. Tutto qua. Rocco e Antonia sono proiettati nella vita più borghese possibile, senza lagnanze, ma in maniera del tutto consapevole.
Quando l’amore è arrivato al suo zenit, inizia la caduta. Antonia si disinnamora di Rocco. Nulla di grave, un semplice processo di disinnamoramento che avviene spesso in età tardo adolescenziale. Ciò che ci sembrava magnifico ieri, oggi non lo è tanto, domani sarà un disastroso ricordo. Tra i due inizia l’allontanamento e si arriva all’abbandono. Ad aggravare la situazione ci pensa Antonia, facendo sesso con un compagno del gruppo in una festa, davanti a tutti, Rocco compreso. L’affronto è doloroso. Rocco si protegge rifugiandosi in un’altra esperienza omosessuale. Proverà poi ad andare a letto con la migliore amica di Antonia ma non ci riuscirà. Lisa, così si chiama la ragazza, non è Antonia, e la vendetta non ha alcun senso, per cui l’eccitazione lascia il passo alla nostalgia. Ma Lisa, a sua volta, era già andata a letto con Antonia. Lisa è femminista, e con lei Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice parlano del femminismo, già comunque ricorrente nel testo nelle pagine precedenti.
Antonia, come Lisa, è femminista, ma la sua amica è la vera trascinatrice in questo campo. Nonostante i buoni propositi, ancora una volta, sembra di essere di fronte a tante belle parole e tanti buoni propositi di poco valore. Lisa, infatti, afferma che “quando si è grasse come Cinzia, il femminismo diventa una dannata via di scampo dalla solitudine e dai complessi”. Poi aggiunge, quasi con disprezzo, che “è inutile continuare a militare il nostro essere donne se poi il primo cazzo è un richiamo così irresistibile”. Si riferisce ad Antonia e alla sua nuova ossessione nei confronti di Carlo, il sostituto di Rocco.
Anche Rocco si professa femminista. Non esserlo poteva creargli problemi. Ma anche volendo essere politicamente corretto non può non ammettere che: “per la sega pomeridiana di solito uso qualche giornalino, di cui bisogna sempre dire che sono tanto volgari da diventar fastidiosi o che sono la peggiore mercificazione della donna fatta dal capitale, ma secondo me sono estremamente gustosi”. Poi a Rocco tanto femminismo fa quasi paura. Quando comincia ad uscire con Antonia una delle prime domande che rivolge alla ragazza è questa: “Senti, ma tu sei proprio tanto femminista? Cioè a me va benissimo anzi anch’io sono femminista, ma mi turba un po’, mi fa sentire come se stessi sempre lì col dito alzato a vedere le cazzate che faccio”.
Le contraddizioni della militanza extraparlamentare riaffiorano quando Lisa e Antonia rimangono nell’intimità della casa di Lisa. Antonia descrive la casa della sua amica in questa maniera: “ogni mobile ha il suo contromobile davanti e sono tutti lucidi, ci si specchia, c’è il salotto, il tinello e le stanze. Poltroncine e scene di caccia sul cretonne rigido che lo ricopre, mi danno una sensazione di vendita all’asta”. L’immagine è di famiglia borghese. Anche Antonia se ne accorge, e quando lo fa notare all’amica questa le risponde a tono facendole un discorso che la lascia senza parole. Le dice che, in fondo, Antonia non odiava la borghesia, ma la piccola borghesia; che suo padre era proletario (il padre di Lisa) ma che l’amica preferiva il padre di Laura che andava a cena con Almirante7 solo perché a casa di Laura nessuno faceva rumore quando qualcuno tirava su la minestra dal piatto. A queste accuse Antonia non si difende e ammette amaramente “ero contenta che lei avesse ragione e io torto”.
Anche se gli anni settanta sono un periodo caratterizzato dalla violenza politica, questa sfaccettatura non entra eccessivamente nelle pagine di questo libro. Abbiamo già citato la morte di un militante dell’estrema sinistra, potremmo citare una considerazione fatta da Antonia: “pensiamo tutti e due che bisogna fare la guerra ma senza divertirsi, che bisogna sparare per vincere e non per sparare eccetera”. È l’unico riferimento concreto alla necessità di impugnare le armi, opinione purtroppo largamente diffusa all’interno della sinistra extraparlamentare di quell’epoca (specialmente in Potere Operaio) (Neri Serneri 2012: 11-61).
Infine, vi sono riferimenti ad avvenimenti di quel periodo. Si cita il golpe in Cile, ci si chiede chi sia Antelope Cobbler, chiaro riferimento allo scandalo Lockheed scoppiato proprio nel 1976, anno di pubblicazione del romanzo, si parla di Luciano Lama, segretario del sindacato comunista CGIL, che sarà duramente contestato, un anno più tardi, nel fatidico anno 1977, da giovani autonomi durante un’assemblea all’Università La Sapienza di Roma8.
5. Conclusione
Il romanzo che abbiamo analizzato va inserito nel contesto storico sociale in cui è stato prodotto. Ha un senso proprio perché figlio del ’68 anche se, dopo un’accurata lettura, possiamo affermare che del Sessantotto evidenzia le numerose contraddizioni più che farne una sviolinata compiacente. La critica, sempre giocosa e mai irriverente, è stemperata dal fatto che i protagonisti sono due adolescenti e, per tanto, contraddittori per natura. Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice producono un romanzo critico nei confronti del tempo che stanno vivendo, evidenziando le false ideologie, il rifiuto della borghesia da parte di persone assolutamente borghesi. Tutte queste valutazioni sono mediate dagli occhi di giovani ragazzi alle prime esperienze associative, amorose e sessuali. Ribelli come sono quasi tutti gli adolescenti, spesso irriverenti, iconoclastici e insofferenti nei confronti della società dei loro genitori.
Il romanzo rimane saldamente incollato alla realtà del suo tempo. Acquista un senso e una logica proprio perché incastonato in quello scenario che a sua volta concede legittimità alle pagine scritte. Il Sessantotto sarà un anno che durerà un decennio e lo si vede in questo romanzo, scritto nel 1976 ma strettamente influenzato dall’onda lunga del ’68. Il ’77 cederà spazio a una nuova generazione, più violenta, meno organizzata. Ci sarà un gap insormontabile tra ’68 e ’77 (Stajano e Fini 1977). Uno dei migliori esempi di questa rottura tra due generazioni di giovani è presente in Ecce Bombo di Nanni Moretti, in cui viene rappresentata la ribellione sognatrice del ’68. È una storia di giovani disillusi e delusi a cui subentreranno altri giovani, molto più incazzati e pronti a tutto. La violenza toccherà da questo momento in poi il suo punto più elevato.
Per quanto riguarda Porci con le ali, potrebbe sorprendere il poco spazio riservato alla violenza, ma in fondo si tratta di una semplice scelta da parte dei due autori, quella di raffigurare dei ragazzi del loro tempo senza per forza caricarli di una moralità. Il romanzo è anzi del tutto amorale. Le scene narrate mescolano sesso libero, opportunismo e una grande confusione ideologica. Tuttavia va ricordato che l’aumento della violenza avverrà soprattutto dal 1977 in poi. Almeno della violenza brigatista, dal momento che già vi erano state le stragi di piazza Fontana a Milano (1969), della piazza della Loggia di Brescia (1974) e del treno Italicus (1974).
Lo stile agile di questo romanzo ne favorisce la lettura, che si fa rapida e contagiosa con il passare delle pagine. Il linguaggio utilizzato è spesso colloquiale. Il registro è sovente basso, specialmente nelle descrizioni dei rapporti sessuali dei protagonisti. Si predilige lo stile diretto, i protagonisti, Rocco e Antonia, raccontano un po’ alla volta e in maniera alternata ciò che accade a loro stessi passando così da una narrazione intradiegetica a una autodiegetica.
In definitiva ci troviamo di fronte a un romanzo generazionale, per nulla acritico né nei confronti dell’epoca descritta, né accondiscendente con la ribellione giovanile. Questo elemento potrebbe sorprenderci prima della lettura dal momento che questo libro ebbe un enorme successo soprattutto all’interno del movimento della Nuova Sinistra e perché venne pubblicato dalla casa editrice Samonà e Savelli, la prima casa editrice italiana della sinistra antagonista e extraparlamentare.
Bibliografia
BALESTRINI, Nanni e Moroni, Primo (1988): L’orda d’oro. Milano: Feltrinelli.
BENJAMIN, Walter (1991): L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Torino: Einaudi.
BERLINGUER, Enrico (28 settembre, 5 e 9 ottobre 1973): “Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile”. Rinascita.
BIANCA, Mariano e GABRIELLI, Patrizia (2009): I linguaggi del ’68. Milano: FrancoAngeli.
CAPANNA, Mario (2007): Formidabili quegli anni. Milano: Garzanti.
CAZZULLO, Aldo (2006): I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. Milano: Sperling & Kupfer.
DALMASSO, Sergio (2001): “La sinistra storica dagli anni ’60 alla sconfitta alla FIAT”. BILLI, Fabrizio, 1960-1980: prima, durante e dopo il ’68. Milano: Punto Rosso, 108-109.
GIACHETTI, Guido (1998): Oltre il Sessantotto. Pisa: Biblioteca Francesco Serantini.
GINSBORG, Paul (1989): Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Torino: Einaudi.
GONZÁLEZ DE SANDE, Estela y CRUZADO RODRÍGUEZ, Ángeles (2010): Rebeldes literarias. Sevilla: Arcibel Editores.
GRANDI, Aldo (2003): La generazione degli anni perduti. Torino: Einaudi.
LANARO, Silvio (1992): Storia dell’Italia repubblicana. Venezia: Marsilio.
MORO, Giovanni (2007): Anni Settanta. Torino: Einaudi.
MUGHINI, Giampiero (2010): Gli anni della peggio gioventù. Milano: Mondadori.
NERI SERNERI, Simone (2012): Verso la Lotta armata. Bologna: Il Mulino.
PASOLINI, Pier Paolo (16 giugno 1968): “Il PCI ai giovani”, L’Espresso.
PERRI, Paolo (2012): “Nazionalità e lotta di classe. La Nuova Sinistra e i nazionalismi periferici”, Diacronie, n. 9, 1.
POLI, Francesco (2003): Arte contemporanea. Milano: Electa.
ROCCO e ANTONIA (1976): Porci con le ali. Milano: Mondadori.
STAJANO, Corrado e FINI, Marco (1977): La forza ella democrazia. Torino: Einaudi.
VALENTINI, Chiara (2004): Berlinguer. L’eredità difficile. Roma: Editori Riuniti.
1 Per approfondire invece sull’arte del dopoguerra, in cui all’assenza dell’immagine si aggiunge l’installazione, si veda Poli, Francesco, Arte contemporanea, Milano, Electa, 2003.
2 Nella pittura del XVI secolo abbiamo esempio di rappresentazione di prostitute nel quadro di Pieter Aertsen, Il figliol prodigo, in cui però il concetto centrale è quello di evidenziare la vita dissoluta di un figlio che nonostante tutto viene riaccettato dal padre. Si può comunque considerare un’opera religiosa. Quanto raffigurato da Goya si allontana dai canoni religiosi.
3 Non va dimenticato che il primo omicidio (in realtà si tratta di un duplice omicidio) realizzato dalle Brigate Rosse risale al 1974, quando alcuni militanti del gruppo terroristico assalirono la sede del Movimento Sociale Italiano di Genova e uccisero due neofascisti che si trovavano nel suo interno.
4 Vi sono numerosi libri che si possono consultare riguardo alla violenza politica in Italia. Mi permetto di consigliarne alcuni: Ceci, Giovanni Mario, Il terrorismo italiano. Roma, Carocci Editore, 2014; Della Porta, Donatella, Il terrorismo di sinistra. Bologna, Il Mulino, 1990; Galli, Giorgio, Il partito armato. Milano, Kaos Edizioni, 1993; Lazar, Marc, Il libro degli anni di piombo. Milano, Rizzoli, 2010; Manconi, Luigi. Terroristi italiani. Le Brigate rosse e la guerra totale (1970-2008). Milano, Rizzoli, 2008; Panvini, Guido, Ordine nero, guerriglia rossa. Torino, Einaudi, 2009; Re, Matteo. Pertenencia a banda armada. Madrid, Biblioteca Nueva, 2013; SILJ, Alessandro. “Mai più senza fucile”. Alle origini dei NAP e delle Brigate Rosse. Firenze, Vallecchi, 1977.
5 Da non dimenticare la morte dello studente Paolo Rossi, precipitato dalle scale della facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma durante i tafferugli scoppiati tra studenti di diversa ideologia. Era il 27 aprile 1966.
6 Si legga il libro di un ex militante extraparlamentare di quell’epoca che oggi è invece critico con quegli anni: Mughini, Giampiero, Gli anni della peggio gioventù, Milano, Mondadori, 2010.
7 Giorgio Almirante, segretario del Movimento Sociale Italiano dal 1969 al 1987.
8 Quello di Antelope Cobbler era un nome in codice dietro cui si pensa che si celasse il presidente della Repubblica Giovanni Leone.