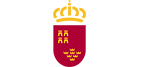Mentalitá provinciale e condizione femminile nella prosa di Carolina Rispoli
Angelo Azzilonna
Universidad de Salamanca
Abstract: Carolina Rispoli rappresenta senza dubbio una delle più originali scrittrici meridionali d’inizio XX secolo. Infatti, la sua prosa nitida e sapiente al contempo risulta particolarmente significativa oltre che coraggiosa; in essa l’autrice affronta e stigmatizza magistralmente la presenza di una forte mentalità provinciale nella sua Melfi natale che orienta costumi, tradizioni ed ogni aspetto della vita quotidiana. A tal proposito, mediante un’analisi dei suoi esordi narrativi e dei suoi primi romanzi che sintetizzano il retroterra socio-culturale locale si analizzeranno vizi e virtù, limiti e potenzialità di una Lucania arcaica e tradizionale attraverso l’interessante prospettiva e sensibilità femminile.
Parole chiave: Narrativa femminile; Basilicata; Critica sociale; Mentalità provinciale; Condizione femminile; Maschilismo.
1. Influenze e motivi della narrativa di Carolina Rispoli
Nella Lucania di inizio novecento scrivere e pubblicare opere letterarie non era un’impresa semplice; come ricorda il critico Mario Sansone,1 va considerata una considerevole emigrazione di cervelli, il bassissimo grado di istruzione, la mancanza di centri culturali e la miseria contadina con forti agitazioni popolari, legate alla scabrosa questione delle terre demaniali. In un simile panorama regionale, caratterizzato da una mentalità patriarcale, appare ancora più meritevole l’impegno letterario della dimenticata Carolina Rispoli2, coraggiosa romanziera melfitana che nel corso della sua produzione narrativa ha saputo offrire un lucido ritratto sulla condizione della donna, indisgiungibile dalla situazione socio-culturale della provincia potentina dell’epoca. In tal modo, le sue opere si rivestono di un’indiscutibile valore documentario circa la vita e la realtà quotidiana piccolo-borghese lucana su cui spesso si incentrava la trama dei suoi romanzi. L’autrice lucana, colpevolmente sconosciuta persino ai suoi corregionali, pur avendo pubblicato diversi romanzi presso case editrici a diffusione nazionale, paga probabilmente l’assenza dei critici che avrebbero dovuto far conoscere ed apprezzare la sua opera almeno entro i confini della sua amata terra. Infatti, Carolina Rispoli, ha scritto ed ambientato molti dei suoi romanzi nella provincia e per la provincia meridionale con il fine di sensibilizzare gli abitanti di una regione eccessivamente arcaica, conservatrice che relegava la donna ad una funzione meramente domestica, in una posizione di irrimediabile subalternità nei confronti dell’uomo. Tuttavia, come evidenzia Raffaele Nigro3 i suoi libri, ammantati da un pacato tono romantico dipingono una società perbenista e benpensante e di conseguenza non hanno suscitato particolare scalpore in quanto la sua protesta non era mai plateale ma sempre sottile ed intelligente. Adesso risulta più agevole comprendere l’esclusione della scrittrice potentina dalla letteratura femminile e femminista, dovuta probabilmente alla presenza di una denuncia troppo moderata verso le retrive costumanze provinciali che ostacolavano qualsiasi tipo di riscatto sociale, economico e culturale della donna lucana.
Giovanni Caserta, uno dei pochi critici e studiosi dell’opera rispoliniana, in occasione della morte della scrittrice, avvenuta nel 1991 ha espresso tutto il suo stupore per il totale oblio nel quale è avvolta la sua narrativa, trascurata persino dagli ambienti intellettuali lucani.4 La romanziera, al contrario andrebbe studiata innanzitutto perché in un contesto culturale deprimente, dove non esistevano giornali e si registrava un elevatissimo tasso di analfabetismo, ha avuto la capacità di fare letteratura dalla periferica provincia lucana e dimostrare la trascendente singolarità della letteratura regionale, partendo dal basso, dall’apparentemente insignificante realtà potentina, contribuendo a ripensare ad un nuovo approccio letterario umile e diretto, ricco di riflessioni sociologiche rivelatrici del microcosmo dal quale sgorgala sua scrittura. Da qualche tempo a questa parte, peraltro, si è cominciato a riconoscere la possibilità e la validità di uno studio regionale della letteratura italiana per ripercorrerla dalla bistrattata periferia. La produzione narrativa della Rispoli, si è rivelata pioniera se si considera la sua intenzionale riscoperta di strati di cultura, rimasti nell’ombra e ritenuti secondari dalla letteratura ufficiale, senza scadere in un caduco regionalismo campanilistico o in velleitarie finalità celebrative, ma nello sforzo sincero di riconoscervi interazioni ed intersezioni con il discorso nazionale, rispettando le specificità autoctone.5La presenza della Rispoli sulla scena letteraria sottende un originale connubio tra il regionale ed il nazionale; evidenzia la ricerca di un nuovo equilibrio di modelli tra continuità e rinnovamento, espressa ed indotta dalla nascita e dalla successiva affermazione di una corrente veristica che in Basilicata ebbe caratteristiche ancora più distintive. In tale ottica, l’opera della melfitana, caricata di valori morali, culturali attraverso descrizioni e simboli evocativi, sembra osservare la realtà regionale lucana con un approccio che si avvale di un indiscutibile realismo sociologico e di un singolare psicologismo asistematico interno6 che la arricchisce di sovrasenso. La prosa rispoliana risulta completa, complessa e moderna innanzitutto perché riesce ad unire la dimensione oggettiva, mediante una razionale e minuziosa descrizione di situazioni ed ambienti della gente di provincia nella sua vita familiare e sociale, con la più intima dimensione soggettiva, grazie alla quale contestualizza la sua ermeneutica, esprimendo la sua visione tra adesione e distacco, tra pietosa compartecipazione e capacità analitica. In essa, si può riconoscere un prolifico nesso fra la propagazione della poetica verista, basata sulla rappresentazione scientifica della realtà sociale e la crescente necessità etica di studiare il preoccupante degrado civile e culturale nonché l’arretratezza regionale che si fondono magistralmente nelle sue pagine. In sintesi, la Rispoli ha saputo costruire e proiettare nei romanzi un’immagine della sua provincia vicina alla realtà effettiva, attraverso la diretta osservazione dei fatti, degli usi e costumi, scandagliando nella sua quotidianità mediante oculate descrizioni, prodotto di una scrupolosa registrazione delle inique relazioni fra l’uomo e la donna e fra le distinte classi sociali. Dunque, Carolina Rispoli, lungi dall’essere considerata una voce minore del panorama letterario meridionale, esclusa dall’analisi della critica, dai manuali così come dalle riviste femministe, meriterebbe un’attenzione ben maggiore dalla cultura lucana, a cui ha dedicato gran parte della sua produzione, e da quella nazionale sia per la qualità della sua prosa, sia per l’impegno e la sensibilità con cui avviò su carte lotte e rivendicazioni femminili, temi del tutto inconsueti per un’epoca e per un ambiente tradizionale non certo adatti a recepirli.
L’impegno civile e femminista rappresentano senza dubbio i due principali poli entro cui si sviluppa e si giustifica la traiettoria letteraria della Rispoli. È interessante notare come tali finalità intrinseche alla sua scrittura si dipanano attorno al focus privilegiato costituito dall’ambiente provinciale potentino tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento. Nello specifico, sin dal suo precocissimo esordio, avvenuto nel 1911, quando non ancora maggiorenne, pubblica una novella originale, Lotta elettorale7che condensa fonti e costanti tematiche della giovane scrittrice meridionale. Di fatti Melfi, la sua cittadina natale è lo scenario ricorrente con i suoi limiti socioculturali e le sue potenzialità etico-morali rispetto ai più moderni e corruttibili spazi urbani. La novella, inoltre sottolinea l’interesse politico della Rispoli e di riflesso ci offre informazioni storiche della misteriosa Basilicata, teatro di numerose e violente agitazioni popolari, al centro delle quali vi era la questione delle terre demaniali8che i contadini combattenti, reduci dalla Grande Guerra pretendevano vanamente da uno Stato che disattendeva le sue promesse, e per questo era avvertito sempre più lontano dalle esigenze dei ceti medio-bassi. L’eco di questa situazione, sempre più incandescente nell’area del vulture-melfese risuona nitidamente nella novella. Quest’ultima rispecchia il fervore con cui la provincia potentina si accingeva a vivere le prime elezioni politiche con il sistema proporzionale e scatenò non poche tensioni tra i partiti conservatori e le emergenti forze popolari e socialiste. In realtà, al di là dell’ambizione politica ed intellettuale, l’esordio letterario serbava già molti dei motivi che ritornano costantemente nel suo percorso narrativo: in primis l’inveterato provincialismo che imprigiona la donna, destinata a patire anacronistiche discriminazioni in una quotidianità desolante ed ingrata. Tuttavia, è il romanzo, il genere letterario preferito dalla Rispoli a cui pare affidare il compito di denunciare, seppur velatamente, il ruolo di angelo del focolare domestico riservato alla donna lucana e descrivere ansie, dolori e speranze di umili ragazze sognatrici, schiacciate dall’immobilistico convenzionalismo della ostile provincia. È facile desumere che il romanzo, proprio in virtù della sua eterogeneità strutturale e tematica, fosse lo strumento più idoneo a veicolare le sue acute ed estemporanee riflessioni su avvenimenti e mentalità della tradizionale Lucania. Il romanzo della Rispoli, ad ogni modo, per forma e per contenuto è irriducibile a riduttive ed escludenti etichette che ridurrebbero il suo vasto raggio d’azione e le sue svariate aree di interesse e di ricerca. Così, all’interno di una stessa opera è possibile apprezzare elementi caratterizzanti il romanzo storico, di costume e di formazione, legati da una propedeutica relazione di causa-effetto. Invece, per quanto concerne le fonti d’ispirazione, l’opera della Rispoli presenta una più limitata omogeneità di motivi, essenzialmente riconducibili alla piccola cittadina di Melfi e per estensione concettuale, alla provincia meridionale con il suo modus vivendi, non toccato ancora dal progresso e dalla modernità. L’eclettismo narrativo, al contrario riguarda il livello stilistico-metodologico, poiché come si approfondirà in seguito, i suoi romanzi descrivono ambienti, vicende e personaggi in chiave verista-regionalista ma con un’evidente valenza storica che le consente di oltrepassare gli angusti confini del provincialismo letterario. In essi, l’immagine e la rappresentazione dell’austera ed incontaminata realtà lucana si costruisce anche attraverso una fine analisi introspettiva di sfortunate fanciulle, il cui profilo psicologico e comportamentale sintetizza la prevedibile vita di provincia. Nelle pagine rispoliane anche lo stile ed il linguaggio adoperati sembrano arricchirsi di studiate sfumature lessicali con cui si esprime il logorante lavorio interiore delle coscienze femminili, così come il desiderio di modificare regole precostituite che spesso causano le tribolazioni, i trasalimenti e gli stati d’animo di pazienti donnine. L’autrice melfitana, salvo poche eccezioni, preferisce affidare le sue tesi circa lo stadio culturale della provincia lucana ad una prosa chiara, fresca con una trama semplice ed essenziale, dove registra azioni e situazioni giornaliere, l’intimità familiare, offrendoci interessanti spunti etnologici da cui emerge la marginalità della donna, gli antichi valori legati alla terra, il peso della posizione della famiglia, le vuote usanze di un mondo immobile. Probabilmente è proprio l’agilità e l’incisività della sua prosa che fa immergere il lettore nell’atmosfera provinciale potentina e che legittima l’onerosa comparazione con Grazia Deledda, come sostenuto nella entusiastica presentazione che Sofia Bisi Albini dedica alla sua prima novella.9
Lontana da compiacenti pretese artistiche e da eccessivi virtuosismi stilistici, in entrambe si può apprezzare un uso della lingua moderno, fluido, privo di ridondanze ma a differenza del verismo militante, riducono l’impiego di espressioni e vocaboli dialettali, utilizzati solo per obbligati riferimenti onomastici e toponomastici, adeguandosi ai limiti unitari nazionali. Come l’autrice nuorese, Carolina Rispoli si lascia ispirare poeticamente dalla sua cittadina natale, onnipresente scenario da cui si irradiano le sue storie, innescando il suo regionalismo sui generis. Entrambe insistevano sul carattere conservativo e quasi immutabile degli usi, dei costumi, delle superstizioni delle rispettive popolazioni dell’entroterra provinciale. In concreto, numerosi passi dei romanzi rispoliani, proprio come quelli deleddiani, seguendo una linea etno-socio-antropologica avvicinano i paesaggi ai personaggi, a volte tipizzati, ma spesso capaci di trasmettere consuetudini, atteggiamenti, modi di vita e folklore locale. I romanzi della Rispoli sembrano risentire l’influenza della Deledda anche nella finalità della sua scrittura in quanto uno degli obiettivi fondamentali della nuorese, riscontrabile anche nella lucana, concerne la riscoperta letteraria delle regioni del Mezzogiorno, del loro background sociale, storico-culturale, non esente da stridenti contraddizioni tra realtà e rappresentatività. Non deve dunque sorprendere la ricorrente presenza della provincia nella narrativa rispoliana, motore e motivo conduttore della stessa. Sin dal primo romanzo, Ragazzeda marito del 1916, è l’ambiente natio che determina e spiega la mesta vita di cinque sorelle, vittime di un ancestrale sistema di valori misogini e formalismi. Anche quando ne Il tronco dell’edera del 1926, la provincia lucana, cede il posto alla città di Firenze, in realtà, la Rispoli pare servirsi della tecnica del contrasto, in quanto in distonia con il tessuto urbano fiorentino, inizialmente idealizzato da un giovane capitano, avverte un nostalgico bisogno di ritornare alla serena solidità della provincia, dove gli era stato combinato un matrimonio con un’onesta ragazza. Dunque, nell’immaginario letterario della Rispoli, il paese d’origine, ben lungi dal rappresentare esclusivamente una gretta ed ipocrita gabbia che ostruisce la piena realizzazione femminile, costituisce un approccio sicuro, protetto, generando un’ambiguità concettuale interpretativa.10Tale malinconica necessità di rientrare presso l’antico nido è ancora più lampante nell’ultimo romanzo, La torre che non crolla, scritta nel 1938. Qui, in effetti si rinsalda il vincolo con la propria realtà che non può ne deve interrompersi mai. Questa volta è Luca Rovello, giovane melfitano che dopo aver affrontato la Prima Guerra Mondiale intraprende la carriera di magistrato, vivendo in diverse città italiane. Queste ultime, si confermano strategici espedienti per risaltare ulteriormente, sotto una diversa luce, la sua cittadina natale, quasi a comprovare una contrapposizione etica ed una funzione moralizzatrice della provincia rispetto all’ibridismo alienante della moderna società urbana, poeticizzando il dolce richiamo delle proprie origini e riaffermando l’insostituibile civiltà e l’identità delle proprie radici. Adesso, risulta più agevole comprendere la pacifica rassegnazione, l’ineluttabile forza del destino che impedisce alle fanciulle protagoniste rispoliane, come a quelle deleddiane, di reagire e protestare contro le ingiustizie, le discriminazioni sessiste presenti nelle regioni di appartenenza. La scrittura della lucana, intrisa di un placido pessimismo, pare tollerare le anacronistiche anomalie della retriva provincia meridionale, senza profilare soluzioni concrete o valide alternative per gli sventurati ed i vinti che affollano le sue opere e verso i quali, tuttavia, nutre una profonda ammirazione per la dignitosa esemplarità e la loro incrollabile fede con cui sopportano egoismo, classismo e soprusi. Oltre all’influenza deleddiana, la natura stilistica e la trattazione tematica dell’autrice melfitana, sembra ereditare elementi riscontrabili nell’opera di un’altra illustre scrittrice quale Matilde Serao.11In tale direzione, un primo tratto comune concerne il gusto per le pittoresche e particolareggiate descrizioni di luoghi e personaggi, rese attraverso efficaci pennellate etno-sociologiche che permettono di penetrare nel clima provinciale. Inoltre, come la Serao, anche la Rispoli, soprattutto nei primi romanzi insiste sull’archetipo femminile, caratterizzando la figura della donna tra fine ottocento ed inizi del novecento di cui ci offre un ritratto poco invidiabile, dimesso e sottomesso allo strapotere maschile che abita senza diritto di cittadinanza, ambienti di cultura misogina. In entrambe le autrici, traspare un realismo psicologico che organizza i disattesi sentimenti delle donne, le loro passioni frustrate che spesso sfociano in impotente passività e momentanei scoramenti personali. Ovviamente, il grigiore quotidiano costituisce un altro punto di contatto, dove è sempre la donna, la vittima per eccellenza che da un lato patisce la routine esistenziale e, dall’altro le insensibilità di fidanzati e mariti occupati e preoccupati eminentemente dalla sfera professionale, non curando affatto quella umana e familiare.12
2. Donna, matrimonio e provincialismo nella narrativa giovanile di Carolina Rispoli
Nella variegata ma coerente produzione letteraria di Carolina Rispoli vi è un microcosmo provinciale che in maniera diretta o indiretta ritorna nella quasi totalità delle sue opere. L’autrice potentina ha saputo descrivere la scabrosa condizione della donna meridionale, così come l’arcaicità della società lucana agli albori del XX secolo, partendo proprio dalla piccola e rappresentativa cittadina di Melfi, angolo d’osservazione privilegiato, capace di riflettere ed interpretare difformità e disuguaglianze di più ampio respiro quali la Questione Meridionale e la subalternità femminile. Già nel suo primo romanzo, Ragazze da marito, sono racchiuse le principali tematiche della sua narrativa che nella periferica provincia scopre la genesi della sua scrittura in quanto prolifico serbatoio di realtà, miti e stereotipi regionali con proiezione nazionale.
Una giovanissima Rispoli, appena ventitreenne, ricostruisce il crepuscolare panorama della opaca e chiusa Melfi natale, entro cui inquadra la scomoda posizione occupata dalla donna. È abile nello scorgere ed evidenziare il peso del determinismo ambientale che condiziona molti aspetti della vita della comunità, decretando tacite regole comportamentali che ledono le facoltà decisionali femminili. È la vetusta mentalità provinciale che orienta l’etica locale, generosa e permissiva con l’uomo, avara e restrittiva per la donna a cui è assegnata una funzione ancillare e servile verso il marito. La Rispoli, attraverso vibranti dialoghi, elogia sperticatamente le virtù da perfetta provinciale di sua figlia, rimarcando esplicitamente le qualità indispensabili che ogni donna decente deve possedere. “Così seria, modesta, di buona famiglia, con una certa dote […] è la più attiva delle mie figliuole; lei sempre in giro a pulire, a strofinare, a cucinare, a cucire”. (Rispoli 1916:87). Risulta lampante e scontato riconoscere dietro tali parametri valutativi, la presenza di un becero maschilismo, che peraltro rimanda ad un altro aspetto patriarcale, ovvero all’unanime e spudorata preferenza delle coppie lucane verso i figli maschi rispetto alle più problematiche femmine. A tal proposito, è opportuno ricordare la presumibile incidenza del misero contesto agricolo potentino, che richiedeva di disporre sin dalla giovanissima età del contributo di nuova forza lavoro o comunque di eredi in grado di continuare le attività lavorative del capo-famiglia.
Di conseguenza, non deve scandalizzare oltre modo la reazione materna allorché lamenta la sua sfortuna di avere nel seno della sua famiglia cinque ragazze ed un solo ragazzo, (Ciccillo), l’unico a cui i genitori permettono e finanziano la realizzazione di studi superiori. Al contrario, alla donna di provincia era preclusa o del tutto rara la possibilità di ricevere un’educazione scolastica adeguata, in quanto, secondo il pensiero dominante dell’epoca e della zona, il campo d’azione e d’espressione femminile si limitava ad una funzione domestica e tuttalpiù demografica. Di riflesso, Carolina Rispoli, con il suo romanzo allude in maniera sottile ma con sfumature polemiche al provincialismo lucano, portatore e custode di un servilismo secolare che ha impedito alla donna di coltivare, educare ed esprimere i suoi talenti, le sue insospettate potenzialità, in nome di un presunto ordine naturale, relegandola ad un secondo piano, in attesa dei cenni di consenso del suo uomo. Infatti, le vicende delle cinque sorelle del romanzo rispoliano, ruotano sempre attorno al claustrale spazio domestico; è solo in cucina dove possono e devono dimostrare le loro abilità di casalinghe e dove trascorrono gran parte delle loro insulse giornate. Come conseguenza, ogni forma di cultura era ritenuta superflua se non nociva e destabilizzante poiché avrebbe potuto suscitare nella donna la fuorviante tentazione di fare carriera o comunque favorire un pericoloso percorso emancipativo, eludendo la sua naturale vocazione. La scrittrice melfitana, per questo non appare sorpresa dalla fragilità psicologica e dalla mancanza di autostima, palesata dalla donna di provincia che, di sovente, nei suoi romanzi dimostra la sua debolezza, la sua incapacità di reazione e di difesa anche quando viene beffardamente derisa ed offesa. In tal senso, sono eloquenti le seguenti parole pronunciate con sufficiente arroganza e disprezzo da un personaggio maschile, Don Peppino Del Prete in merito alle rivendicazioni femminili che proprio in quegli anni intraprendevano le prime battaglie per il diritto al voto, esigendo la loro presenza nella vita pubblica e politica. “Qui, anche le creature parlano di politica? […].Adesso le donne reclamano il suffragio […] anche le pettegole delle donne! Ci vorrebbe pure questa! Pensassero a fare la calzetta, che la marmaglia da sola è anche troppa.”(Rispoli 1916:175). Ad ogni modo, è da apprezzare lo strategico tempismo della Rispoli, che dalla sperduta e maschilista provincia potentina, in tempi non ancora maturi, lancia un implicito messaggio a favore del suffragio universale per le donne, sebbene attraverso frasi di scherno che sottolineano il desiderio delle donne di partecipare attivamente alla politica nazionale. In Ragazze da marito, la scrittrice enfatizza l’abitudine femminile ad una aprioristica obbedienza agli ordini dell’uomo patendo la sua prepotente autorità. Le donne non riescono mai a riflettere razionalmente circa la loro infelice situazione e a formarsi un consapevole concetto della stessa. In tale ottica, il temperato femminismo della Rispoli si avvale di uno stratagemma narrativo per smuovere la coscienza del lettore: l’impiego di monologhi e di un calibrato discorso indiretto libero in cui sono gli stessi uomini a pronunciare espressioni e frasi autocritiche, e denunciare le problematiche derivanti dal deleterio maschilismo lucano che vanifica qualsiasi progetto di vita futura e preoccupa non solo le sorelle direttamente interessate ma anche il padre di famiglia, l’avvocato Forgiuele.
E quelle femmine, almeno l’uomo può muoversi, può agire, può lavorare, può aprirsi una strada, qualunque essa sia, a qualunque costo; ma le femmine, quelle povere ragazze, allevate nella tranquillità, rigida e monotona della famiglia, incapaci di lavoro e di lotta, inesperte della vita, tirata su solo per la famiglia e pel matrimonio, quale sarebbe stato il destino di quelle ragazze se non si fossero maritate? Povere anime sperdute, povere anime abbandonate, poveri esseri deboli (Rispoli 1916: 209).
In poche righe, l’autrice liquida elegantemente il secolare e deprecabile patriarcato provinciale che trovava terreno fertile nelle aree interne del potentino; ne prende le distanze e pare individuare in esso il colpevole che ha compromesso i diritti delle donne ad affermare la propria personalità e capacità da offrire a se stessa ed alla comunità. Tali coercizioni ambientali ed esclusivismi maschili acuivano la carenza di civismo e di progresso sociale di una regione come la Basilicata che agli inizi del 1900 presentava un’allarmante involuzione storica, almeno in parte imputabile alla mancata partecipazione della donna ai processi civili. Nel complesso, il romanzo fa emergere la necessità delle incolte ed indifese donne di provincia di evadere dalla penalizzante realtà locale, di sognare un riscatto personale, un’ascesa socio-economica, spesso identificata con il matrimonio che determina una spasmodica ed avvilente caccia al marito. L’opera della Rispoli rileva ogni dettaglio che contraddistingue questa affannosa ricerca coniugale che calpesta il loro orgoglio e la loro dignità giacché si prostrano ad estenuanti attese che logorano la loro gioventù, nelle speranza di trovare una sistemazione familiare e garantirsi quella sicurezza e quel benessere che da sole non possono raggiungere. È il matrimonio l’unica meta agognata dalle pazienti ragazze della cittadina melfese; esso rappresenta un imprescindibile rito di accettazione e convenzione sociale nella comunità lucana grazie al quale la donna regolarizza la sua funzione di moglie e futura madre. Tuttavia, la scrittrice dimostra come persino nella fase di fidanzamento, essa sia un “oggetto” in mano alla volontà e ai capricci umorali dell’uomo. Nessuna delle sorelle Forgiuele, e più in generale nessun personaggio femminile della narrativa rispoliana riesce a sconfiggere la dolorosa dipendenza emozionale nei confronti del potenziale marito. Alla ragazza di provincia viene negata la libertà di scelta poiché, sintetizzando il pensiero di Maria Teresa Imbriani,13il matrimonio costituiva un’obbligazione dettata da esigenze morali e materiali in cui amore e interesse possono coincidere.
Era paga adesso, contenta, quasi felice di quel matrimonio convenuto, e non per avidità soltanto, non soltanto per l’avvenire assicurato, ma più d’ogni altro pel matrimonio in se stesso, per quel matrimonio non d’amore, da lei prima non richiesto, né desiderato […]. Giacché alla maggior parte delle donne, specialmente alle meridionali, il matrimonio qualunque esso sia, è necessario, non disponendo di altri mezzi di vita (Rispoli 1916: 63-64).
Esso, nell’immaginario femminile assurge a simbolo e strumento di emancipazione in grado di conferire un nuovo status e prestigio alla sposa che acquisiva maggior rispetto e carisma nel vicinato, potendo adesso espletare tutte le peculiarità femminili. La pragmatica e spicciola filosofia provinciale segnala l’indiscussa utilità di contrarre matrimonio, corroborata sul piano linguistico da campi semantici anti poetici, in grottesco contrasto con l’ideale romantico che dovrebbe caratterizzare la fase del fidanzamento. Ad esempio, la Rispoli, indica senza mezzi termini l’importanza per le ragazze di possedere una buona dote per aspirare ad un matrimonio di livello, associando lessicalmente con crudo realismo le possibilità matrimoniali al patrimonio e all’eredità, oppure comparando il dolce gioco seduttivo della conquista amorosa ad una fredda e calcolata trattativa.
L’ossessiva finalità matrimoniale si ripresenta puntuale nel secondo romanzo della Rispoli, Il nostro destino, scritto nel 1923, dove l’autrice ripropone tematiche affini che si ricollegano al consunto scenario provinciale potentino, accentuando la tendenza fatalistica che grava sul destino delle donne. Con un realismo di stampo psicologico e intimistico si commentano i particolari stati d’animo e il delicato processo di crescita di due fanciulle, Bice e Lucietta, appartenenti alla piccola borghesia melfitana del primo novecento, vissute in comunanza sin da piccole, di cui si seguono le vicissitudini personali, abbracciando un lasso temporale di dieci anni durante il quale si plasma la loro diversa identità. Come nel precedente romanzo, la Rispoli conferma la sua maestria nel tratteggiare e relazionare la forma mentis delle protagoniste al demotivante ambiente che ancora una volta, livella ed appiattisce le loro qualità e le loro aspirazioni umane sin dalla tenera età. Di fatti, è di nuovo il matrimonio a fungere da catalizzatore delle loro energie, da implacabile condizionante ed unica possibile conquista nella grama vita di provincia. È la meta che illumina il cammino di ogni donna melfitana a intorno a cui si costruiscono sogni ed illusioni. In tale ottica va interpretata l’insolita organizzazione del tempo libero e dei momenti di svago infantile, dove Bice, la più risoluta delle due, suggerisce alla più schiva e romantica Lucietta di giocare, simulando situazioni e varianti matrimoniali. “No, no, giochiamo io e te, ma senza bambole. Facciamo gli sposi. Facciamo che la sposa vuole lo sposo e la madre non vuole… Ah? Come Leonora D’Amato che abita vicino a noi. Anzi vogliamo fare proprio Leonora? Tu sei Leonora, io sono donna Rosina, la madre”. (Rispoli 1923: 12).
La Rispoli enfatizza la maniacale centralità del matrimonio che monopolizza persino l’oziosa spensieratezza dell’infanzia e suscita prematuri turbamenti nell’animo e nella fantasia delle fanciulle, facendo risaltare la loro incapacità di godersi la ludica e disinteressata amenità che dovrebbe accompagnare l’età puerile. Allo stesso modo, non stupisce che durante le consuete mansioni domestiche, la fantasia femminile viene spesso sollecitata dall’idea dell’unico evento, considerato momento capitale in grado di riscattare la precaria ed insignificante esistenza provinciale, depositario di tutte le speranze giovanili. La scrittrice palesa un atteggiamento comprensivo verso le fitte confessioni e trepidazioni delle sue corregionali, indotte loro malgrado a vedere nel matrimonio l’ unico stimolo e snodo cruciale con cui poter aggirare la mediocrità del paese. La Rispoli, però, tralascia un altro plausibile motivo che invece giustifica la precocità delle nozze nella Basilicata del 192014, interpretabile infatti anche come la risposta al soddisfacimento dei bisogni sessuali15. In realtà, pur senza offrirci una chiave di lettura ed un’esegesi relativa alle inibite esigenze fisiologiche femminili prematrimoniali, diversi passi del suo romanzo rimandano alla ferrea e bigotta eticità provinciale che con le sue leggi di onorabilità, decenza e decoro “demonizza” gli impulsi naturali provenienti dalla sfera sessuale. Ad esempio, risalta il rigoroso pudore lucano attraverso la rigida ed austera figura della madre che incute soggezione e conseguente inibizione nella giovane Lucietta, costretta a lanciare furtivi e fugaci sguardi verso l’attraente Antonino Giuliani, approfittando delle parziali distrazioni materne.
Antonino Giuliani andava, di tanto in tanto, in casa Russo, in apparenza per visitare Ernesto di cui era amico, ma in realtà per vedere Lucietta. Lucietta dolcemente esigeva quelle visite, e, quando egli arrivava, la gioia le raggiava dagli occhi grigi […]. Ma poi sedeva e non parlava quasi più, temendo di tradirsi, temendo la severità materna. Solo quando la madre si voltava dall’altra parte, ella alzava gli occhi dal lavoro e fissava lui e si perdeva nella contemplazione di lui (Rispoli 1923: 107)
La Rispoli ricalca la determinante influenza della mentalità paesana che orienta i costumi ed i comportamenti provinciali, servendosi di aneddoti locali, presentati talvolta con una certa dose di ironia che compensa l’amaro realismo delle sue pagine. Emblematica risulta la figura della consorte del cavaliere Alessandro Russo, appartenente a sua volta ad una delle più borghesi e ricche famiglie melfitane che durante una cerimonia matrimoniale calamita le attenzioni di tutti i presenti. La donna, infatti, per diverse ragioni, diventa una valvola di sfogo con cui gli invitati sublimano, almeno parzialmente, i loro bassi e spesso frustrati istinti. L’esotica ed appariscente signora innesca le voluttuose e represse fantasie sessuali degli uomini giacché personifica quell’eleganza, quello stile seduttivo assente nel depresso contesto potentino. “La scrutavano tutta, dai capelli nerissimi alla punta sottilissima del piede, in una vampa di desiderio che inaridiva le loro gole, che faceva tremare le loro vene. Le loro fantasie galoppavano come cavalli senza freno. Ognuno si immaginava presso di lei, solo con lei.” (Rispoli 1923: 105). La scrittrice, a volte si serve dello stereotipo della donna urbana per smascherare ulteriori limiti e difetti delle donne locali; così la sensuale e raffinata torinese è motivo di curiosità prima e d’invidia poi da parte delle provincialotte che presenziavano il banchetto. La Rispoli costruisce un prototipo femminile destinato a suscitare scalpore e stupore per via del suo abbigliamento moderno e del suo atteggiamento disinvolto e sbarazzino che improvvisamente irrompe e sconvolge il placido e monolitico moralismo del luogo. La forestiera in tal senso, convoglia i timori della popolazione autoctona poiché con le sue toilette se soprattutto con il suo modus operandi disinibito, autentico e brillante costruisce una minaccia, un elemento estraneo perturbatore per il consolidato ed ipocrita perbenismo provinciale. Essa, inoltre, permette di svelare un’ennesima malsana abitudine di molte donne melfitane: il pettegolezzo. In reiterate occasioni, esso è il risultato della noia che attanaglia la vita di paese, tuttavia, nel caso dell’episodio della donna settentrionale, secondo la lettura rispoliana, si tratta di una reazione femminile collegabile ad un possibile complesso di inferiorità delle rozze donne di provincia, incuranti dell’importanza dell’estetica e delle buone maniere e che adesso avvertono la loro popolana grossolanità. Anche l’introduzione della figura della mezzana, in un certo modo, è il risultato della noiosa vita quotidiana, priva di eventi e sussulti. In verità, la presenza della sensale, presente già nel precedente romanzo della Rispoli, conosce una significativa e calcolata metamorfosi. Nello specifico, in Ragazze da marito, il ruolo di donna Chiarina possiede una finalità concreta, motivata da favori e compensi economici promessi dalla famiglia Forgiuele, in cambio del raggiungimento dell’ossessivo obiettivo matrimoniale e del previo fidanzamento da parte di ingenue ragazze, private peraltro delle normali situazioni informali e socializzanti, idonee alla conoscenza dei loro coetanei. Invece, ne Il nostro destino, la figura dell’intermediaria appare disinteressata ed il suo sostegno per la ricerca di un marito non risponde a sordide logiche lucrative bensì al puro e mero desiderio del chiacchiericcio, derivante dagli incontri combinati tra il giovane potenziale fidanzato e la famiglia della futura sposa che offrivano una valida scusa per entrare nelle dimore altrui, commentare ed aggiornare poi alle comare e al vicinato le varie fasi e relativi esiti della negoziazione. Emerge come in entrambe le opere, la scrittrice impieghi il personaggio della mezzana con distinta valenza ma sempre e comunque per far affiorare le storture del retrogrado ambiente lucano. La Rispoli, in realtà, forse perché cosciente del tedium provinciale che rendevano interminabili le giornate, sembra comprendere la maliziosa arte del pettegolezzo alla quale dedica un’intera pagina in cui elenca le diverse tipologie di pettegolo dove, tuttavia, condannando tutti al contempo li assolve tutti.
Il pettegolezzo è la passione, è la vita della provincia […]. Troverete in provincia una varietà infinita di gente pettegola quante infinite sono le varietà degli umani temperamenti. Il pettegolo silenzioso che ascolta moltissimo e molto pensa, ed il pettegolo ciarlone che poco pensa e molto parla […] e il pettegolo pedante cha da tutto saprà trarre un insegnamento […]. Troverete tutto, infine, salvo questo: un uomo e una donna che non siano pettegoli. (Rispoli 1923:119-120)
La scrittrice, analizza con una prospettiva alquanto ambigua se non giustificazionista la mania dello spettegolare sul matrimonio, sui fidanzamenti o sulle visite di forestieri, unici eventi capaci di animare le discussioni nel torpore della squallida atmosfera provinciale. Il paragrafo intitolato Nelle giornate provinciali, è nello specifico una fucina di descrizioni e considerazioni sui costumi locali tra cui spicca l’effimero e gratuito curiosare, il criticare esperienze e progetti altrui. Strettamente connessa alla monotonia da provincia appaiono altri vizi del comportamento femminile: l’invidia e la gelosia; si pensi alla malcapitata donna settentrionale che attira le maldicenze e le perfide attenzioni delle donne melfitane a causa del notevole charme seduttivo che esercitava verso gli uomini del paese. La romanziera con una vena pessimistica sembra esprimere il suo cocente disincanto dovuto allo sgretolamento insperato dei valori positivi come la solidarietà, la compartecipazione tra donne, ben evidente sull’infastidito volto di Bice nel momento in cui la sorella era prossima alle nozze. Lo sguardo rispoliano capta l’invidiosa rivalità che impietosamente non si arresta nemmeno dinanzi ai vincoli di sangue. In modo analogo, la prosa della scrittrice lucana, in alcuni passi, demitizza la sacralità dell’amicizia, benché elemento spesso essenziale e confortante nel corso della vita e della relazione delle due fanciulle protagoniste che comincia a vacillare allorché Bice, l’amica di sempre, trova l’amore, diventando motivo di lacerante invidia per Lucietta.
Il regionalismo letterario della Rispoli si sviluppa mediante sapienti e rapidi tocchi di costume con cui ricostruisce spaccati della società lucana, criticando alcune delle sue norme. In tal senso va inquadrata la velata condanna della frivola apparenza, inseguita e preservata dalla gente del paese, su cui si fonderanno i temuti giudizi pubblici che sono alla base dell’equilibrio e del rapporto quotidiano tra l’individuo e la comunità. I romanzi giovanili della Rispoli, insistono ad esempio sull’importanza per le donne di trovare un buon partito e di causare un’ottima impressione alla famiglia dell’ipotetico marito da cui deriva il goffo e paesano sfoggio dei migliori abiti attraverso cui si distingueva il rango delle stesse ed ostentare un benessere spesso fittizio, a volte semplice reminiscenza di una perduta ricchezza. La narrativa rispoliana ed in particolare le numerose pagine dedicate all’analisi di banchetti e cerimonie ufficiali di vario tipo, affermano una perfetta equivalenza abito/identità dove l’abbigliamento delle donne provinciali voleva essere specchio di precisi comportamenti, atteggiamenti e stili di vita, finalizzati a persuadere il resto degli invitati; dunque, gioielli e vestiti, sono impiegati come canali di comunicazione e di informazione che creavano un’allusiva e generale illusorietà. Il romanzo smaschera con distaccato sarcasmo la dubbiosa moralità vigente nella Melfi di inizio novecento, le sue ipocrite imposizioni moralizzanti che determinano una stucchevole inautenticità. Gli strali polemici della Rispoli inglobano e manifestano una religiosità di comoda facciata dove anche le feste cristiane, come può essere quella del giovedì Santo, diventano pretestuose occasioni per farsi notare in pubblico, simulare fervore e raccoglimento. Si assiste ad una strumentale spettacolarizzazione della fede da parte della folla, tra cui Lucietta che finge una sentita spiritualità, e profferisce meccaniche preghiere al passaggio della tomba del Cristo morto durante la processione pasquale.
Ora ella avrebbe voluto raccogliersi, cercar di rivivere quell’emozione, piangere ancora su quella tomba millenaria. Ma era tardi, ed una gran folla, varia, spesso irriverente, spessissimo fredda e distratta di curiosi, cominciava ad invadere la chiesa. In quell’ora la gente elegante va a visitare i sepolcri. Le chiese con il loro apparato luminoso, abbacinante di candele, offrono alla curiosità dei visitatori come uno splendore fittizio di scenario. (Rispoli 1932: 62)
Più imbarazzante è l’episodio del bacio sul collo ricevuto dalla fanciulla da parte di Antonino Giuliani, il quale approfitta della calca e della confusione collettiva. La Rispoli, fortemente credente, pare far leva su questa indicativa scena per sottolineare al lettore che in definitiva le celebrazioni religiose erano i soli momenti di ozio concessi alle donne e di conseguenza, non deve stupire se vengono utilizzati per sedurre e provare l’ebbrezza del contatto fisico con l’altro sesso. In modo identico, la chiesa si configura come l’unico spazio fisico, oltre a quello domestico, concesso e consigliato ai rari svaghi femminili. Proprio nel luogo di culto religioso, la scrittrice ubica un’altra sintomatica scena, stigmatizzando il diffuso peccato della vanità provinciale che sottende insicurezza, miseria materiale e psicologica. Qui, infatti, il tronfio orgoglio con cui una madre si mostra sottobraccio al figlio professore, in realtà rivela oltre che un implicito classismo paesano, una probabile vita previa di povertà ed insoddisfazione della donna che ora riesce finalmente a mostrare e dimostrare pubblicamente la sua rivincita nella scala sociale, attraverso la professione filiale, trascendendo i limiti della condizione precedente. Le sagaci e circostanziate descrizioni rispoliane non risultano mai superflue; tutti i dati, i vestiti, i gesti, i riferimenti alle attività lavorative di protagonisti e comparse, si ricoprono di significati a volte patenti a volte latenti, contribuendo a ricreare il panorama provinciale del periodo. È una scrittura che oscilla fra l’aspetto denotativo e quello connotativo, tra l’oggettività e la soggettività, dove ciascun dettaglio assume una duplice valenza, tangibile e simbolica al contempo, garantendo una più esaustiva visione e percezione della realtà circostante. Tuttavia, Il nostro destino, pur inserendosi nel solco della condizione femminile, con immutati contrassegni ideologici sui rapporti di classe e fra i sessi, propone alcune novità sostanziali in grado di ampliarne l’area tematica. La Rispoli, perciò introduce un importante binomio che unisce la personalità e l’educazione, intesa quest’ultima anche con i suoi contenuti ed insegnamenti culturali. Nello specifico, per la prima volta nel suo itinerario narrativo, un personaggio femminile viene accostato alla letteratura con presumibile riferimento autobiografico. Non invano, Bice, presentata sin da bambina come una scolaretta modello e nell’adolescenza come un’insaziabile lettrice di impegnative opere letterarie (Omero, Dante, Petrarca, Goethe), riesce a costruire una più solida e consapevole identità psicologica16rispetto all’amica Lucietta. La scrittrice lucana, dunque, rimanda al cruciale ruolo che la cultura può svolgere nella formazione umana delle donne, apportando conoscenza, sicurezza, autostima; si pensi alla snella e paritaria nonchalance con cui Bice discute di specifici argomenti letterari con Antonio Russo. La Rispoli, già nel secondo romanzo pare segnalare l’educazione culturale come potente strumento risolutivo ed efficace antidoto con il quale modificare la condizione d’inferiorità femminile; senza di essa il comportamento delle donne di provincia difficilmente si sarebbe elevato oltre il piano naturalistico e la primitiva spontaneità istintiva, condannandola a rimanere schiava delle leggi deterministiche delle natura e del dispotico dominio maschile. La parte conclusiva del romanzo, presenta un altro elemento sorprendente ed inusuale nella narrativa rispoliana in quanto si invertono le asimmetriche relazioni tra i due sessi, ritraendo un uomo (il professor Bonnone), a patire le decisioni di una donna (Bice). Così, l’autrice stravolge gli squilibri sentimentali abituali e ci mostra un personaggio maschile che soffre e teme un eventuale abbandono, sperimenta quella dipendenza emozionale associata di solito alle donne delle sue opere. Soprattutto, sembra scalfire quella prevedibile ed escludente dicotomia affettiva, attribuendo inoltre, eccezionalmente virtù e valori caratterizzanti le sue umili donnine, quali l’abnegazione, la tolleranza, la capacità di sopportazione, di sacrificio e la fedeltà al sensibile Bonnone. Tuttavia, il finale del romanzo, seguendo una fatalistica struttura circolare, in cui apertura e chiusura coincidono, segnala un brusco ritorno all’ingrato destino riservato alla donna, condannata fin dai tempi di Eva ad una dolorosa ed immodificabile incompletezza e dipendenza dall’uomo, mitigata solo in parte dalla solidale comprensione femminile e dalla compartecipazione del dolore, assente in altri frangenti del romanzo.
Bibliografía
BRONZINI, G. (1987): Vita tradizionale in Basilicata. Galatina: Congedo.
CAGNOLATI, A. (2014): “Tra gli spazi e il silenzio: la condizione della donna nella narrativa di Carolina Rispoli (1893-1891)”, Blanco Valdés, C. et alii (eds.), Il Mezzogiorno italiano. Riflessi e immagini culturali del Sud d’Italia. Firenze: Franco Cesati Editore, vol. II, 71-80.
CASERTA, G. (1989): “Il primo novecento”. Appunti per una storia della cultura e della letteratura lucana. Boll. Prov.le Matera n.15-16, a. X, 43.
— (2001): Questioni di letteratura lucana. Matera: Elicopy.
DE PILATO, S. (1928): Nuovi profili e scorci. Potenza: Marchesiello.
GASTALDI, M. (1936): Panorama delle letteratura femminile contemporanea: Milano: Gastaldi.
IMBRIANI, M.T. (2000): Appunti di letteratura lucana: ventisette ritratti dal Medio Evo ai giorni nostri: Potenza, Consiglio Regionale della Basilicata.
MORTARA, G. (1910): Le popolazioni di Basilicata e di Calabria all’inizio del secolo ventesimo. Roma.
NIGRO, R. (1978): La cultura a Melfi. Nota bibliografica. Melfi: Ed. Interventi culturali.
RISPOLI, C. (1911): “Lotta elettorale”. Vita femminile italiana, n.5, a. V, 518-547.
— (1916): Ragazze da marito. (Con prefazione di Sofia bisi Albini) Milano: R. Quintieri.
— (1923): Il nostro destino. Milano: Unitas.
SANSONE, Mario (1969): “La letteratura in Basilicata”. Il contributo storico e culturale dato dalla Basilicata all’Italia e al mondo, Atti del LIX, Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, Potenza, 8-12 settembre 1968, Roma, 23-39.
SPINELLI, T (1985): Per una storia della letteratura lucana del 900. Napoli: Loffredo.
1 Il critico letterario Mario Sansone, in occasione del LIX Congresso internazionale organizzato dalla Società Dante Alighieri illustra nel suo articolo La letteratura in Basilicata, in Il contributo storico e culturale dato dalla Basilicata all’Italia e al mondo, Roma, 1969, pp. 23-39, traccia un quadro particolarmente dettagliato circa il ritardo culturale della Basilicata, analizzando i fattori e le conseguenze di tale isolamento e le oggettive difficoltà dei suoi intellettuali nel comunicare e diffondere il loro pensiero.
2 Carolina Rispoli nasce a Melfi in provincia di Potenza nel 1893. Della sua vicenda biografica è utile ricordare che la sua innata passione letteraria fu corroborata e motivata dallo storico e politico rionerese Raffaele Ciasca che nel 1922 diviene suo marito e soprattutto fondamentale figura carismatica a cui dedica gran parte della sua produzione narrativa. La Rispoli muore quasi centenaria a Roma nel 1991 ma viene sepolta nella sua cittadina natale.
3 Inoltre, lo scrittore Raffaele Nigro, ne La cultura a Melfi. Nota bibliografica, Ed. Interventi culturali, Melfi, 1978, p. 78 è tra i pochi studiosi della Rispoli che scorge nell’opera della sua concittadina numerosi spunti ironici che le conferiscono una vivacità descrittiva soprattutto nel trattare ed interpretare le usanze e gli atteggiamenti provinciali melfesi.
4 A tal proposito Giovanni Caserta, docente ed esperto di letteratura lucana, nel suo saggio intitolato Questioni diletteratura lucana, Elicopy, Matera, 2001, p.95, è particolarmente duro verso la stampa locale, la Rai regionale e l’Amministrazione comunale di Melfi che in occasione della sua morte avvenuta nel 1991 non hanno fatto alcuna menzione ufficiale, ne hanno organizzato alcuna manifestazione in suo ricordo.
5 Il critico pugliese Michele Dell’Aquila, nell’introduzione all’opera di Raffaele Nigro, La cultura a Melfi, op. cit. p. 5, auspica un maggior interesse verso gli apporti provinciali, rivendicando la necessità di far riaffiorare anche in ambito letterario, dopo un lungo ed ingiusto oblio anche gli strati meno appariscenti delle culture locali e poter riequilibrare in questo modo il valore nazionale con l’articolazione regionale nella storia letteraria.
6 Tito Spinelli, in Per una storia della narrativa lucana del 900,Loffredo, Napoli, 1985, p. 132 riconosce ed evidenzia un eclettismo stilistico e metodologico nella narrativa rispoliana che in tal senso, secondo lo studioso arricchisce il suo realismo di fondo con prospettive interpretative provenienti da altre discipline quali la psicologia, la sociologia, con cui l’autrice lucana riuscirebbe a captare anche quegli aspetti meno visibili e meno tangibili della “lucanità”.
7 Rispoli, C., “Lotta Elettorale” in Vita femminile italiana, n.5, a.V, pp. 518-547, 1911 rappresenta infatti il brillante e precoce esordio letterario della Rispoli, cruciale poiché che in questa novella dimostra una indubbia passione politica, ma al contempo il suo interesse verso le fragilità e le sensibilità femminili, qui rappresentate da una ingenua ed innamorata Matilde che patisce l’ingratitudine del suo uomo.
8 Per una panoramica esaustiva e precisa sul contesto storico-sociale della Basilicata agli inizi del novecento si può consultare Giovanni Caserta, Il primo Novecento, in “Appunti per una storia della cultura e della letteratura lucana”, in Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera, anno X, n. 15-16, 1989, p.43, dove lo storico materano effettua una minuziosa analisi sulle svariate cause che avevano portato a episodi cruenti di rivolta contadina che non risparmiarono nemmeno il politico rionerese Giustino Fortunato, tradizionalmente schierato con i ceti medio-bassi.
9 Nello specifico, Sofia Bisi Albini, nella prefazione a Ragazze da marito del 1916, primo romanzo della Rispoli, esalta la scrittura rispoliana soprattutto per via della sua primitiva originalità e della sua freschezza mediante un lusinghiero e promettente paragone con Grazia Deledda.
10 Il giurista e critico letterario potentino Sergio De Pilato nel suo volume Nuovi profili e scorci, Marchesiello, Potenza, 1928, pp-95 sottolinea l’equivoca valenza che riveste nella narrativa rispoliana l’idea di provincia poiché se da un lato riceve le critiche, sia pur velate dell’autrice per gli evidenti limiti sociali, economici e culturali che presenta, dall’altro funge da rifugio privilegiato che permette una vita tranquilla, semplice e serena e consente di riscoprire le proprie radici e le proprie tradizioni che tuttavia critica in molti aspetti e passi dei suoi romanzi.
11 Il Gastaldi in Panorama della letteratura femminile contemporanea, Quaderni di Poesia, Gastaldi, Milano, 1936, p. 511 sottolinea la probabile influenza esercitata dalla illustre narratrice Serao sull’opera della Rispoli, evidente soprattutto nella caratterizzazione dei personaggi femminili e nelle minuziose e vivide descrizioni dei ceti più umili degli ambienti partenopei che tra verismo e psicologismo letterario avrebbero lasciato indelebili tracce nella lucana.
12 In particolare è il famoso romanzo La virtù di Cecchina, pubblicato a Catania nel 1884 quello che più legittima e giustifica la comparazione tematica con l’autrice lucana giacché sintetizza magistralmente la banale ed insulsa vita quotidiana di una donna trascurata dal marito che potrebbe aver inciso sull’idea e sulla costruzione di personaggi femminili della Rispoli che, come nell’opera della Serao patiscono le disattenzioni coniugali e pressioni ambientali.
13 Maria Teresa Imbriani, docente di letteratura italiana presso l’Università di Potenza, a tal proposito, nella sua miscellanea Appunti di letteratura lucana: ventisette ritratti di autore dal Medio evo ai giorni nostri, Consiglio Regionale di Basilicata, Potenza, n.3, 2000, pp.137-139, sottolinea con crudo realismo le anomalie e la sottomessa condizione della donna lucana di inizio novecento, vittima di un sistema sociale e di una grettezza provinciale in cui soltanto attraverso il matrimonio poteva migliorare la sua condizione economica e la reputazione morale.
14 L’antropologo materano Giovanni Battista Bronzini in Vita tradizionale in Basilicata, Congedo, Galatina, 1987, p.177 riporta dati statistici che indicano come, nel 1910 in media la donna lucana si sposava trai 16 anni ed i 18 anni.
15 A tal proposito, nell’opera di Mortara G., Le popolazioni di Basilicata e di Calabria all’inizio del secolo ventesimo, Roma, 1910, pp.61-132, oltre ai fattori di ordine morale che spingevano le donne a reprimere i loro istinti sessuali, vengono individuati alcuni dei plausibili fattori che ostacolavano l’esercizio e la diffusione della prostituzione nell’area del potentino, quali l’isolamento socio-culturale e geografico, la mancanza di grandi centri urbani nella vicinanze, di classi agiate, di forti guarnigioni militari e di presenze turistiche.
16 In tal senso particolarmente interessante è l’articolo presentato dalla studiosa Antonella Cagnolati, Tra gli spazi e il silenzio: la condizione della donna nella narrativa di Carolina Rispoli che in occasione del XII congresso della S.E.I. (Sociedad Española de italianistas), svoltosi a Cordoba nell’ottobre del 2014. Nello specifico, la docente di letteratura italiana presso l’Università di Foggia ha ben evidenziato l’incidenza del fattore educativo nel parallelo ma differente processo formativo delle due protagoniste del romanzo, Bice e Lucietta nonché le conseguenti ed opposte ripercussioni sul carattere e sulla personalità delle stesse.