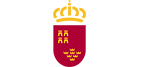Storie segrete: la vita delle donne raccontata da Hilary Mantel
Tiziana Ingravallo
Università degli Studi di Foggia, Italia
Riassunto: L’ambientazione in Arabia Saudita è un altro punto prospettico scelto da Hilary Mantel per raccontare la storia delle donne, una storia fatta prevalentemente di prevaricazioni e repressioni. In particolare la vita delle donne è esaminata in relazione alle forme di potere. Le tensioni politiche della sfera pubblica si riflettono con effetti più nefasti nella sfera privata. Perciò il racconto del viaggio e della permanenza dell’inglese Frances a Jeddah assume i tratti di un romanzo gotico.
Parole chiave: Narrativa contemporanea; Mantel; Vite; Repressione; Stato.
L’inglese Hilary Mantel è tra le voci più significative della letteratura contemporanea mondiale. È l’unica scrittrice-donna ad aver ricevuto per ben due volte, nel 2009 e nel 2012, l’importante premio anglosassone, il Man Booker Prize. È noto ormai il suo talento per la narrativa storica. Le due ultime trilogie, grazie alle quali si è imposta al grande pubblico, riportano in vita misteri e nefandezze della Rivoluzione francese e della corte di Enrico VIII. Benché questi ultimi romanzi si confrontino con eventi fondativi della storia europea, è bene notare che la Mantel ha posto sempre come tema centrale della sua prolifica produzione, sia narrativa che saggistica, la ridefinizione della soggettività femminile. Predilige le ‘storie di vita’ e tale vocazione è già confermata nel 2003 nell’autobiografia romanzata Giving up the Ghost. Sono per lo più storie di donne e, talvolta, la narrazione di quelle vite non pone palesemente le presenze femminili nei ruoli di protagoniste. Le loro vite si configurano, con un preciso intento di poetica e una rispondente strategia narrativa, come ‘storie segrete’. La storia delle donne racconta del faticoso e quotidiano affrancarsi dall’unica versione possibile a cui l’ideologia dominante o la storia ufficiale le ha relegate. Paradigmatica è la scelta dell’ultimo romanzo di Hilary Mantel, Bring up the Bodies (2012), in cui si propone il personaggio di Anna Bolena come caso esemplare del confronto di una figura femminile con la sovranità politica, per di più in ragione del suo status politico di regina. Si narra in tal caso tutto ciò che i libri di storia hanno tralasciato di raccontare, ovvero, gli ultimi giorni di vita fino alla condanna a morte di colei che ha influito su un nuovo assetto politico-culturale dell’Inghilterra moderna.
La narrativa della Mantel pone più volte l’interrogativo su come le forme di potere organizzino e determinino le vite umane. Tale riflessione è esplorata in diversi contesti culturali e storici, poiché è mossa dall’esigenza primaria di esaminare la condizione delle donne in diverse epoche e a diverse latitudini. Prima ancora della trasposizione più recente di questi temi in accurati affreschi storici, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, la Mantel sperimenta la trasposizione geografica, prima con il romanzo Eight Months on Ghazzah Street (1988), ambiento a Jeddah, in Arabia Saudita, e successivamente nel 1994 con A Change of Climate, ambientato in Sud Africa. Nel 1995 An Experiment in Love ripropone lo scenario inglese. Attraverso il percorso di crescita della protagonista Carmel, che si confronta prima con la rigidità del sistema educativo e più tardi con la complessità del sistema di classe, si ricostruisce la vita delle donne durante i turbolenti e contraddittori anni ’70.
In particolare, la restrizione di genere è il tema su cui ruotano le diverse storie, sancito nella sua ineluttabilità nel romanzo dedicato ad Anna Bolena in cui la decapitazione è il finale ben noto di quel personaggio storico che la Mantel propone come icona di genere. È, pero, nel 1988 con Eight Months on Ghazzah Street che la scrittrice inglese affronta per la prima volta queste tematiche con risvolti scottanti, facendo luce sul trattamento oltraggioso delle donne in Arabia Saudita e, più precisamente, sugli effetti nefasti dell’apartheid compiuto sulle donne saudite.
È un romanzo audace e schietto, il più apertamente politico. Gli usi e i costumi della vita saudita sono rievocati magistralmente. La Mantel aveva familiarità col posto, avendo vissuto in Arabia Saudita per quattro anni. Avvalendosi dell’esperienza personale, dà prova in questo romanzo della sua proverbiale capacità descrittiva degli ambienti e dei personaggi. Specie la vita delle donne è esplorata nella sua ricchezza e varietà di classi e di culture: da una parte la prospettiva occidentale della protagonista Frances e delle altre figure femminili che gravitano nella cerchia della comunità di espatriati, dall’altra quella delle donne native saudite e delle immigrate delle nazioni limitrofe. La vera forza umanamente avvincente del romanzo si sintetizza nel gesto simbolico che più donne compiranno al cospetto dell’occidentale Frances, ripetutamente e in diversi punti del romanzo. Sollevano il velo per annullare la rappresentazione simbolica di sé e per raccontare le proprie vite, per esprimere i propri desideri, timori e aspirazioni. L’amicizia femminile e la condivisione empatica dei propri tormenti, prerogativa che attraversa tutta la narrativa della Mantel, pone i presupposti di ciò che Rosy Braidotti (2003) definisce “femminile virtuale”, vale a dire, il femminile non come contenuto dato socialmente e storicamente, invece, come potenziamento dell’essere e come apertura a divenire altro. Nota un personaggio maschile, riconoscendo una comunanza del vissuto femminile: “all you women together in the flats, you’ve got to know each other, that’s nice, and you’re sure to talk amongst yourselves. What do they say, women are the same the whole world over?” (Mantel 2013: 240)
Sarà la vicina Yasmin ad aprire per la prima volta la porta della sua casa e a togliersi il velo per un primo confronto tra diverse culture: «You must try to understand a little the Saudi viewpoint» (Mantel 2013: 70). Infatti è Frances a detenere il punto prospettico da cui è possibile accedere alla realtà delle altre donne e alla nuova geografia del luogo. Non si abbandonano mai le sue impressioni, i suoi giudizi, e i suoi sguardi che si rifrangono e si ripetono talvolta ossessivamente e claustrofobicamente in una modalità discorsiva variabile: dalla trascrizione diaristica alla narrazione in terza persona, con una focalizzazione interna che lambisce lo stream of consciousness.
Il viaggio a Jeddah di Frances sarà compiuto per raggiungere il marito, Andrew Shore, ingegnere civile che ha accettato un impiego redditizio per conto di una compagnia britannica ingaggiata per edificare un opulento complesso per il governo saudita. Sarà senz’altro un’esperienza meno dura e angosciante rispetto a quella vissuta dall’altra coppia di coniugi del romanzo A Change of Climate che affrontano il viaggio e la permanenza all’estero spinti da motivazioni filantropiche. È, comunque, il sofferto travaglio di una coppia che si ‘avventura’ oltre i confini conosciuti. Si ritrovano più o meno volontariamente in quel luogo, un tempo avamposto coloniale. Come espatriati, avvertono un senso di terrore alle prime rivelazioni dei costumi locali, in particolare rispetto al sessismo sostenuto e perpetrato dallo stesso Stato. Con spirito di adattabilità cercano di persuadersi che le prime impressioni possano essere riconsiderate dopo il primo impatto con quella cultura. Troppo tardi, invece, scopriranno la vita segreta che li circonda, una verità ancora più brutale, artatamente nascosta, rispetto a una realtà già poco piacevole.
Jeddah è un luogo che sfugge alla comprensione persino di una cartografa come Frances. Negli assetti sempre temporanei e mutevoli della città, e perciò non riproducibili in mappe, persino fluida e mobile è la linea che divide il mare dalla terra ferma. Anche la cerchia di espatriati, in prevalenza americani e britannici, sembrano intorbiditi da quel regno del deserto ricco di petrolio. E infatti, il romanzo porta alla luce un mondo poco noto, offrendo una fotografia spietata sia della comunità di espatriati che dei nativi, sia delle rapaci compagnie estere che dei corrotti apparati statali, perché la geografia “kafkiana” di quel luogo invade le viscere di ogni individuo.
Poiché tutto cambia nei domini di quel regno, anche il legame tra Andrew e Frances Shores subisce i condizionamenti delle strutture simboliche e ideologiche dello Stato. Il ménage di coppia all’occidentale subito si incrina sotto i colpi di un’autorità statale repressiva. Fa notare Yasmin a Frances: “Jeddah is a good place for famiglie” (Mantel 2013: 69), rendendo ben chiare le dinamiche di vita all’interno delle tradizionali strutture socio-simboliche che fanno perno su Stato, famiglia e autorità maschile, peraltro ben raffigurate nel personaggio di Raji, marito di Yasmin e politico colluso con i poteri forti.
Frances, infatti, metterà da parte la sua vita lavorativa per assolvere in quel luogo al solo compito di moglie. Con intenti analoghi sviluppati nei romanzi storici più recenti, in Eight Months on Ghazzah Street il displacement geografico è di per sé una regressione al passato. Il viaggio, preannunciato nel capitolo iniziale con il viaggio in volo della protagonista, assume i connotati di una visione in cui il mondo reale retrocede. Sono vite, quelle con cui si confronterà Frances, dominate da leggi del passato. Sin dal giorno del suo arrivo ne sperimenterà e condividerà tutte le limitazioni, specie come donna. E in questo senso l’esperienza di dislocazione di Frances le consentirà di contemplare più nitidamente le differenze di cultura e di genere. Centrale, dunque, è la ridefinizione della soggettività femminile con l’obiettivo di affermare e rappresentare varie forme di soggettività, a loro volta espressione di una soggettività molteplice e stratificata che recupera la memoria storica della propria appartenenza. Anna Bolena, le ragazze degli anni ’70, le donne saudite, sono le molte vite vissute e le molte vite virtuali, tutte appartenenti a un passato patriarcale. La ridefinizione della soggettività femminile implica che si lavori su concetti e rappresentazioni dell’identità femminile così come sono stati codificati dalle diverse culture e dalle diverse età, poiché il nuovo si crea rivisitando il vecchio e la differenza si genera nelle interminabili ripetizioni. Non è un caso che sia Frances, una cartografa, tra le prime protagoniste della Mantel, ad assolvere il compito di una prima rielaborazione fedele delle proprie origini. Frances rileverà nella ritualità del caffè una dimensione ripetitiva dei momenti in cui si fa uditrice delle testimonianze e delle confessioni ‘senza veli’ delle donne: “She leaned forwards and refilled Shabana’s cup. The movement seemed dreamlike, endlessly repeatable. She had done it for Yasmin, for Samira; six months of it. Pouring coffee, she thought, and passing it through the bars of our respective cages.” (Mantel 2013: 228) Allo stesso modo, l’ultima trilogia storica della Mantel racconterà la storia delle regine di epoca Tudor. Non solo, dunque, Anna Bolena, anche chi l’ha preceduta, Caterina d’Aragona, e chi le succederà, Jane Seymour e le innumerevoli storie di donne rinascimentali, che si intrecciano nella narrazione, segnate da repressioni e privazioni. Se le identità sono mutevoli, ma al tempo stesso contingenti e retrospettive, è importante mettere a fuoco nella storia quello che le donne sono già state per operare una trasformazione profonda rispetto a quello che possono diventare. La molteplicità femminile, secondo Braidotti, è un’esperienza sedimentata, non dispersiva, ma cumulativa.
In virtù di tale principio, vi è anche da parte della Mantel, l’affermazione di un innegabile spazio comune dell’azione letteraria femminile, con una sua cultura autonoma e innovatrice, consapevolmente vissuta e posseduta nel suo mutare. Costantemente sono richiamate le proprie ‘madri’ letterarie, da Jane Austen a Virginia Woolf e la letteratura radicata esclusivamente nell’esperienza femminile. Perciò, il mondo arabo femminile è raccontato passando in filigrana, talvolta con rovesciamenti tragici e dolorosi, topoi e situazioni archetipiche dei romanzi della tradizione letteraria inglese che pongo come epicentro narrativo la vita delle donne. È evocata la segregazione della Pamela di Richardson con la registrazione dei minimi eventi quotidiani. E, infatti, il periodo trascorso nella solitudine delle mura domestiche condannerà Frances alla sofferta disciplina dell’analisi e conoscenza di sé, meticolosamente trascritta nella parola più marginale tra le scritture femminili, quella, appunto, diaristica. Il diario di Frances dà voce al suo stato di malessere, pur se in un continuo esercizio di autocontrollo che la induce spesso ad intercalare la registrazione della realtà materiale intorno a sé e a delegare alla narrazione in terza persona la trascrizione della realtà più sfuggente. L’esperienza dello spaesamento, della dislocazione e della segregazione contrassegna il sorgere della coscienza femminile. L’allucinante disciplina dell’isolamento è condizione primaria per affinare lo sguardo visionario femminile. È, infatti, la pesante monotonia e claustrofobia a indurre Frances alla presa di coscienza di un crescente pericolo che avverte entro le mura del suo palazzo.
È negata a Frances la peregrinazione nelle strade della città compiuta dalla Clarissa della Woolf. Prova a sue spese, prima ancora che le venga spiegato, che non può camminare sola per le strade polverose senza attrarre osceni commenti. Dovrà attraversare la città sempre in macchina. Pertanto, l’altro sguardo possibile sul paesaggio urbano è dal terrazzo del palazzo in Ghazzah Street, abitato esclusivamente da famiglie saudite, assegnato dalla compagnia di lavoro di Andrew per la loro permanenza a Jeddah, distante, peraltro, dai compound, residenza abituale degli espatriati. Sin da subito la città apparirà avvolta in un caldo soffocante e in una bruttura impersonale per la rapace cementificazione che depreda continuamente i lotti vacanti di terra e ne cambia repentinamente la sua fisionomia e la toponomastica. Osservata dall’alto, in una prospettiva di distanziamento, Jeddah diventa un luogo privo di spessore esperienziale e nella mente di Frances la proliferante crescita disegnerà una confusa sovrapposizioni di immagini.
La privazione della partecipazione alla vita della città, all’outer space, ha come effetto l’accrescimento delle sequenze narrative sviluppate negli interni e negli spazi domestici, nell’inner space, che fanno il più delle volte da cornice, come in Mrs. Dalloway, a mogli alle prese con la preparazione di cibo e di feste. Frances vorrebbe come i personaggi femminili della Woolf un dialogo con i luoghi reali e concreti della collettività, vorrebbe un’espansione del microcosmo tutto interiorizzato verso il macrocosmo della città.
Man mano che acquisisce consapevolezza di ciò che la circonda, non è la nuova città di recente costruita a diventare il fulcro della narrazione, ma i drammi privati di oppressione e disperazione che si compiono dietro le eleganti facciate. I giornali riferiscono cauti racconti di mogli adultere lapidate a morte. E anche il tetro appartamento in cui vive nasconde una storia, quella della donna che in precedenza lo occupava. La porta di ingresso murata la proteggeva dagli incontri accidentali con i vicini.
Il motivo dei “vicini” è più volte reiterato nel romanzo, ed è bene ricordare che nella narrativa di Jane Austen, la piccola comunità che si costituisce da quei legami e da quegli incontri, come si conviene ad un romanzo sociale, mette in moto l’intreccio narrativo e pone in essere i principali avvenimenti. Altrettanto meticolosa è la costruzione narrativa della Mantel, la noia soffocante del luogo, inizialmente provata da Frances, sarà sostituita dall’orrore. Un tensione progressivamente e lentamente crescente volgerà verso una fine misteriosa che cattura il lettore in presagi, suspense, allusioni e misteri sinistri e violenti. Bene, dunque, si adatta la definizione di genere impiegata da Joyce Carol Oates (2003): “a dark commedy of manners”. Senza reticenza, la narrazione si innerva sugli oltraggi della società (sparizioni di intrusi, mutilazioni di ladri, imprigionamenti di donne, lapidazioni di adultere), tanto da acquisire l’andamento di una storia gotica. La violenza scuote gli ultimi capitoli del romanzo e sembra porsi come l’inevitabile conseguenza delle tensioni che imperversano nella cultura araba contemporanea e dell’ignoranza e della grossolanità della comunità di espatriati. Un permanente e sottaciuto senso di minaccia avvolge il confronto tra culture, le comprensioni e i fraintendimenti che ne derivano, per gli eccessi del fondamentalismo da una parte e un’insidiosa influenza di avidità e grettezza dall’altra.
Ancora una volta, infatti, la Mantel si sofferma sul tema del male, che nelle trilogie storiche più recenti, si mostrerà nella perversa sottomissione degli eventi pubblici a malevoli personalità, mentre in A Change of Climate si espliciterà nell’impatto del colonialismo e in An Experiment in Love nel sistema di classe britannico.
Come Foster e Conrad, la Mantel ritrae gli accadimenti più duri e malevoli come proiezioni di timori o desideri dei viaggiatori europei. Frances si trasforma in una nuova Catherine Morland, la protagonista del romanzo gotico di Jane Austen, Northanger Abbey, confusa tra mondo reale e immaginario. I rumori provenienti da un appartamento creduto vuoto, somiglianti per Frances a soffocati lamenti presumibilmente di donna, stimolano la sua “neurotic imagination” già messa a dura prova dal buio costante del suo appartamento dalle finestre blindate. Come è tipico delle scritture femminili, la realtà muta sotto gli occhi di chi la contempla e lo sguardo va oltre i bordi del visibile. Sono la morte di un amico e il tentativo di Yasmin di lasciare il regno con un complotto ai danni del marito, inspiegabilmente collegati, a profilare agli occhi di Frances una realtà ben diversa, che resta pur sempre sfuggente.
Quei vicini musulmani restano misteriosi, specie Yasmin che recitava il protocollo della moglie araba. Il grande tema della narrativa della Austen, il processo di conoscenza dell’Altro e della realtà, registra la sua fallibilità, impigliato irreversibilmente tra false impressioni e pregiudizi. Non è possibile comprenderli e decifrarli come in una detective story. Ognuno ha la sua versione e i suoi segreti, compresi quelli di Stato. “Life is not like detective stories. There is a wider scope for interpretation. The answer to all questions that beset you are not in facts, which are the greatest illusion of all, but in your own heart, in your own habits, in your limitations, in your fear.” (Mantel 2013: 274-275).
Negli incontri, però, tra “vicine” qualcosa di duraturo resta. La condivisione femminile di reciproche contaminazioni e influenze disegna le identità femminili come identità interconnesse grazie alle quali è possibile divenire altro (Braidotti 2003). Frances trasfonde nel suo alter ego arabo, Yasmin, la libertà dell’immaginazione femminile, “the Third Eye” lo definisce nel suo diario, (forse per la polizia religiosa, lo Stato, o il marito, un immaginazione malata) che è possibile realizzare solo con la fuga (l’“exit visa”è il desiderio di tutti gli espatriati), ma si paga a duro prezzo.
Bibliografia
BRAIDOTTI, Rosi (2003): Metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire. Milano: Feltrinelli.
BUTLER, Judith (2013a [1997]): La vita psichica del potere. Milano-Udine: Mimesis.
— (2013b): A chi spetta una buona vita? Roma: Nottetempo.
MANTEL, Hilary (2012): Bring up the Bodies. London: Fourth Estate.
— (2013 [1988]): Eight Months on Ghazzah Street. London: Harper Collins Publishers.
OATES, Joyce Carol (2003): “Stranded in the Dark”. The New York Review of Books, Volume 50 (16): 16-18.
RENNISON, Nick (2005): Contemporary British Novelists. London and New York: Routledge.
WAUGH, Patricia (1989): Feminine Fictions. Revisiting the Postmodern. London and New York: Routledge.